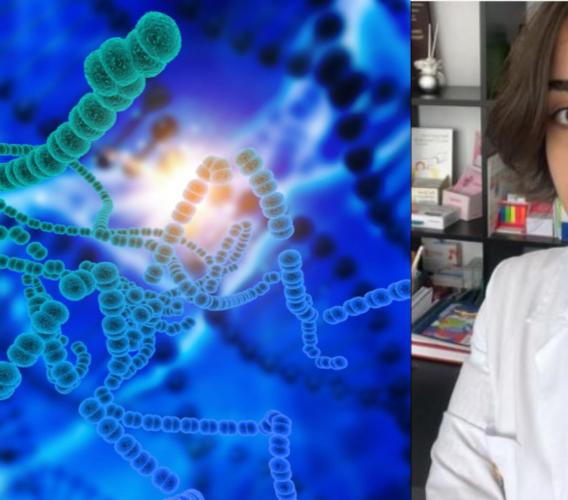
di Vanessa Carletti

"Il falso mito della sete: se la senti, sei già disidratato". Ecco la formula per sapere quanto bere
Con l'arrivo delle temperature più fresche, tendiamo a dimenticarci di bere. In estate, la sete ci accompagna come un promemoria naturale, ma in autunno e inverno il meccanismo si fa più silenzioso e rischiamo di ridurre troppo l'apporto di liquidi. Eppure, la sete è già il primo campanello d'allarme della disidratazione: aspettare di avvertirla per bere significa essere in ritardo rispetto al fabbisogno reale del nostro corpo. L'acqua è essenziale: regola la temperatura corporea, favorisce la digestione, trasporta nutrienti e ossigeno alle cellule, sostiene la funzione renale e mantiene elastiche le articolazioni. Basta una perdita del 2% del peso corporeo in liquidi perché le performance cognitive e fisiche inizino a risentirne. Eppure, spesso la consideriamo un dettaglio. Basta pensare che l’organismo umano è composto per circa il 60% da acqua per apprezzarne l’importanza. Quanta acqua serve realmente? Le linee guida generali indicano circa 2 litri al giorno per le donne e 2,5 per gli uomini, ma ogni persona ha fabbisogni diversi. Un metodo semplice consiste nel calcolare 30-35 ml di acqua per ogni kg di peso corporeo: per esempio, una persona di 70 kg dovrebbe assumere circa 2,1-2,45 litri al giorno. Inoltre, in alcune condizioni i bisogni cambiano ulteriormente. Durante gravidanza e allattamento, ad esempio, i fabbisogni aumentano sensibilmente, perché l'acqua serve sia per sostenere i processi metabolici della mamma che per la produzione di latte. Gli sportivi, invece, devono considerare le perdite attraverso il sudore: un'ora di attività intensa può richiedere anche un litro di liquidi in più, da reintegrare non solo con l'acqua ma anche con sali minerali se la sudorazione è molto abbondante. Per i bambini è importante ricordare che hanno un fabbisogno idrico maggiore in rapporto al peso corporeo rispetto agli adulti e spesso non riconoscono da soli i segnali della sete, mentre gli anziani possono percepirla meno e rischiare di disidratarsi senza accorgersene. Anche in alcune condizioni patologiche, come malattie renali, cardiache o intestinali, le quantità di liquidi da assumere devono essere valutate insieme al medico curante, perché le necessità cambiano in base alla situazione clinica. Non solo acqua “pura”: tisane non zuccherate, infusi, minestre e persino acque aromatizzate senza zuccheri aggiunti contribuiscono all’idratazione quotidiana, rendendo più facile raggiungere i fabbisogni senza forzare il consumo di bicchieri extra. Anche la scelta dell’acqua ha la sua importanza. Non tutte le acque sono uguali: quelle con residuo fisso basso sono più leggere e indicate per un consumo quotidiano regolare, mentre quelle con residuo fisso più alto, ricche di minerali come calcio e magnesio, possono essere utili in situazioni particolari, ad esempio per chi pratica sport intenso o ha esigenze specifiche di integrazione minerale. Per bere di più nella vita quotidiana basta adottare qualche strategia semplice e naturale. Tenere sempre a portata di mano una borraccia, ad esempio, aiuta a ricordarsi di assumere liquidi regolarmente, mentre iniziare la giornata con un bicchiere d’acqua permette di reidratare il corpo dopo il sonno. Anche impostare piccoli promemoria sullo smartphone può essere utile per non dimenticarsi di bere durante la giornata. Sostituire bevande zuccherate con acqua, aggiungere fettine di limone, foglie di menta o cetriolo per aromatizzarla senza calorie e bere un bicchiere d’acqua prima dei pasti sono tutti accorgimenti che rendono più facile raggiungere il fabbisogno quotidiano. Senza dimenticare che molti alimenti, come frutta e verdura, contengono naturalmente molta acqua e contribuiscono in modo significativo all’idratazione complessiva. Bere abbastanza non è un gesto banale: significa prendersi cura di concentrazione, energia, pelle, reni e articolazioni, e prevenire malesseri legati a disidratazione anche lieve. Con l’arrivo della stagione fredda, ricordiamoci che l’acqua resta un alleato quotidiano e silenzioso, da ascoltare e integrare in ogni momento della giornata, adattando quantità e tipi di liquidi alle nostre esigenze individuali.

Obesità, la sfida del nostro tempo tra genetica e ambiente
Oggi parlare di obesità significa parlare di una vera e propria malattia cronica, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e non semplicemente di una “questione estetica” o di scarso autocontrollo. L’obesità è una condizione multifattoriale: entrano in gioco la genetica, la biologia, i fattori psicologici, ma soprattutto l’ambiente in cui viviamo. Ed è proprio questo il punto: mai come ora ci troviamo immersi in un contesto che rende estremamente facile accumulare peso e molto più difficile perderlo. L’ambiente moderno è infatti “obesogenico”, cioè, favorisce lo sviluppo dell’obesità. Basta osservare le nostre giornate: ci muoviamo sempre meno, passiamo ore davanti a computer e schermi, ci spostiamo in auto anche per brevi distanze, mentre gli spazi per il gioco libero e l’attività fisica spontanea si sono ridotti. Sul piano alimentare siamo circondati da cibi ultraprocessati, disponibili a basso costo, pronti da consumare e progettati per stimolare il nostro cervello con sapori intensi e irresistibili. Il marketing e la pubblicità amplificano questa esposizione, influenzando in modo particolare i bambini. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: per la prima volta nella storia, nel mondo ci sono più bambini che soffrono di obesità che in condizione di sottopeso. È un dato che fa riflettere e che non può essere ignorato, perché segna un cambiamento epocale. L’eccesso di peso in età pediatrica non è un semplice problema passeggero: aumenta il rischio di diabete, malattie cardiovascolari e disturbi metabolici già in giovane età, oltre a incidere sulla qualità della vita e sul benessere psicologico. Non possiamo dimenticare che ogni persona reagisce in modo diverso: c’è chi, a parità di ambiente, ingrassa di più e chi di meno, e questo dipende dalla combinazione di fattori genetici, ormonali e comportamentali. Tuttavia, quando l’ambiente spinge nella stessa direzione, diventa molto difficile “resistere” con la sola forza di volontà. È come cercare di nuotare controcorrente: possibile, ma faticoso e per pochi. Per questo la lotta all’obesità non può essere scaricata solo sulle singole persone. È necessario un impegno collettivo: dalle famiglie, che possono proporre ai bambini abitudini alimentari sane e occasioni di movimento, alle istituzioni, che dovrebbero favorire la disponibilità di cibi freschi, regolamentare il marketing aggressivo verso i più piccoli, progettare città più vivibili, con spazi verdi e percorsi sicuri per andare a scuola a piedi o in bicicletta. Riconoscere che viviamo in un ambiente obesogenico non significa arrendersi, ma acquisire consapevolezza. Solo capendo che il problema non è del singolo ma del contesto, possiamo costruire soluzioni efficaci e restituire alle persone la possibilità di vivere in armonia con il proprio corpo.

Le fibre: il “carboidrato dimenticato” che aiuta la performance sportiva
Quando si parla di alimentazione e sport la mente corre subito ai carboidrati da carico, alle proteine per i muscoli o agli integratori “giusti”. Le fibre restano invece in secondo piano, come se fossero un dettaglio marginale, eppure la ricerca scientifica le sta riportando al centro. Una recente revisione apparsa su Sports Medicine le definisce addirittura “il carboidrato dimenticato” nelle raccomandazioni per gli atleti. Non assumerne a sufficienza non dà sintomi immediati, ma può emergere nei momenti chiave: in una salita in bici, in una gara di lunga durata o in una serie intensa di allenamenti, quando digestione lenta, gonfiore, cali glicemici o affaticamento percepito diventano ostacoli concreti alla performance. Uno studio condotto su giocatori di basket, ad esempio, ha mostrato che chi consumava quotidianamente circa 17 grammi di fibre solubili non migliorava forza o velocità in senso stretto, ma riferiva una percezione di fatica significativamente più bassa rispetto al gruppo placebo. È un dato interessante, perché ci ricorda che lo sport non è fatto solo di numeri e cronometri, ma anche di sensazioni: sentirsi meno stanchi può significare allenarsi meglio e più a lungo, affrontare lo sforzo con maggiore serenità e recuperare con più efficacia. Altri lavori hanno confermato che un apporto stabile di fibre, soprattutto quelle fermentabili come i beta-glucani presenti in avena, orzo e alcuni funghi, sostiene il microbiota intestinale, che a sua volta produce metaboliti antinfiammatori utili nel recupero muscolare e nella protezione dei tessuti. Il legame tra fibre e sport diventa evidente se pensiamo a cosa succede durante una salita o uno sforzo prolungato: un intestino in equilibrio stabilizza l’assorbimento degli zuccheri e previene oscillazioni glicemiche troppo brusche, riducendo così i cali di energia nei momenti decisivi. Un adeguato consumo di fibre significa anche meno fastidi gastrointestinali, digestione più efficiente e maggiore disponibilità di energia per i muscoli, invece che “sprecata” in discomfort. E quando arriva il momento del recupero, le fibre aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione, accelerando i tempi di ripresa e migliorando la qualità degli allenamenti successivi. Naturalmente, non si tratta di spingere al massimo l’assunzione: troppe fibre nei pasti vicini alla gara o a un allenamento intenso possono causare crampi, pesantezza o disturbi intestinali. Per questo la strategia migliore è modulare l’introduzione: aumentare gradualmente fino a raggiungere i 25-30 grammi al giorno, distribuendoli nei pasti lontani dalla performance e privilegiando le fonti solubili. Fondamentale anche abbinare un’adeguata idratazione, perché le fibre trattengono acqua e il loro effetto benefico dipende molto dal giusto equilibrio con i liquidi. Le fibre, insomma, non sono un dettaglio della dieta, ma un tassello silenzioso e prezioso per chi fa sport. Non aumentano i watt né abbassano i tempi in modo diretto, ma possono determinare la differenza tra una prestazione che regge e una che crolla, tra un recupero lento e uno più rapido. E soprattutto ci ricordano che, nello sport come nella vita, a volte ciò che sembra “secondario” è in realtà la chiave per affrontare le salite — reali o metaforiche — con più forza e leggerezza.

Settembre è il mese dei fichi: proprietà, benefici e falsi miti da sfatare
Il mese di settembre porta con sé un frutto che racconta la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: il fico. Dolce, succoso e avvolto in una buccia che va dal verde brillante al viola intenso, il fico non è solo una delizia stagionale, ma anche un alimento prezioso per la nostra salute. Spesso viene guardato con sospetto, accusato di essere “troppo zuccherino” e quindi poco adatto a chi vuole mantenere il peso sotto controllo. In realtà, come accade spesso con i pregiudizi alimentari, la verità è più sfumata: i fichi freschi hanno un contenuto di zuccheri paragonabile a quello di altri frutti comunemente consumati, come mele o kiwi, e se inseriti in una dieta equilibrata possono essere gustati senza timori. Dal punto di vista nutrizionale, i fichi freschi sono una fonte interessante di fibre, utili a favorire il senso di sazietà e a sostenere la regolarità intestinale, oltre a contribuire al controllo della glicemia. Contengono inoltre potassio, importante per la salute cardiovascolare, e calcio, che li rende particolarmente preziosi per ossa e denti. Non mancano le vitamine del gruppo B e diversi antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Un ruolo di primo piano spetta alle antocianine, pigmenti naturali che conferiscono alla buccia dei fichi il caratteristico colore violaceo e che svolgono un’azione protettiva per cuore e vasi sanguigni, contribuendo a ridurre il rischio cardiovascolare. Per questo motivo consumare i fichi con la buccia non è solo sicuro, ma anche consigliabile: è lì che si concentra gran parte delle fibre e degli antiossidanti, antocianine comprese. Diverso il discorso per i fichi secchi: la concentrazione di zuccheri e calorie è più alta e rende importante consumarli con moderazione, pur restando un alimento ricco di proprietà Ma oltre ai numeri ci sono le storie. In Italia è da sempre considerato un frutto “popolare”, legato alla vita contadina. Rappresentava una riserva di energia naturale per chi lavorava nei campi e spesso veniva essiccato per garantire scorte durante l’inverno. Inoltre, in molte regioni italiane il fico fresco veniva gustato semplicemente con pane e formaggio o accompagnato al prosciutto crudo. Un’abitudine che oggi riscopriamo come perfetto esempio di abbinamento tra fonti di carboidrati, proteine e fibre. Accogliere i fichi a tavola, quindi, significa non solo godere di un frutto stagionale che la natura ci offre generosamente, ma anche sfatare un falso mito che rischia di farci perdere il piacere di mangiarli. Un paio di fichi freschi come spuntino, in insalata con formaggi freschi o nello yogurt della colazione, non solo arricchiscono di gusto la giornata, ma portano benefici concreti al nostro organismo. Se non li avete ancora messi nel carrello, questo è il momento giusto: i fichi sono nel pieno della loro stagione. Non temeteli per la loro dolcezza, perché è proprio grazie a quell’equilibrio naturale di zuccheri, fibre e micronutrienti che diventano un alleato prezioso per la salute.

Non mettiamo i bambini a dieta: accompagniamoli a crescere bene
Quando si parla di alimentazione dei più piccoli, capita spesso che l’attenzione di genitori e nonni si concentri sul peso. Alcuni bambini vengono descritti come “troppo magri” o, al contrario, “in carne”, e da qui nasce la tentazione di “metterli a dieta”. Ma i bambini non sono adulti in miniatura: sono in una fase delicata della vita in cui l’organismo ha bisogno di energia e nutrienti per crescere in salute. Imporre restrizioni può sembrare una scelta protettiva, ma rischia in realtà di compromettere lo sviluppo fisico e psicologico, creando carenze nutrizionali e lasciando segni profondi sull’autostima. Secondo l’indagine del 2023 di OKkio alla Salute (progetto nazionale che indaga le abitudini, i fattori di rischio e lo stato ponderale dei bambini delle scuole primarie), in Italia 1 bambino su 5 è in sovrappeso e 1 su 10 soffre di obesità, con un 2,6% in obesità grave. Dopo un miglioramento iniziale, i dati si sono fermati e il problema resta diffuso. A pesare sono soprattutto le abitudini quotidiane: colazioni saltate o incomplete, merende troppo abbondanti, poca frutta e verdura, troppi snack e bibite zuccherate, mentre i legumi — fondamentali nella crescita — vengono consumati troppo raramente. Numeri che raccontano quanto sia urgente educare a uno stile di vita più equilibrato, fatto di buone scelte e non di privazioni. Non è solo questione di alimentazione: lo stile di vita conta altrettanto. L’indagine rivela che 1 bambino su 5 non svolge alcuna attività fisica, mentre quasi la metà passa oltre due ore al giorno davanti a uno schermo tra TV, tablet e cellulare. Anche il movimento più semplice, andare a scuola a piedi o in bicicletta, è ormai raro: più del 70% viene accompagnato in auto, perdendo così preziose occasioni di attività fisica spontanea. Numeri che ci ricordano quanto sia importante restituire ai bambini tempo per muoversi, giocare e vivere all’aria aperta. Questi numeri raccontano che il problema non è il singolo bambino “in carne”, ma l’insieme delle abitudini familiari e sociali che favoriscono sedentarietà e scelte alimentari poco equilibrate. Per questo parlare di “dieta” in senso restrittivo non è la strada giusta. Un bambino che cresce con l’idea che il proprio corpo non vada bene rischia di sviluppare insicurezza, conflitto con il cibo e, nei casi peggiori, disturbi del comportamento alimentare che possono durare tutta la vita. L’obiettivo non deve essere la restrizione, ma l’educazione: insegnare che il cibo è nutrimento, energia e piacere, non un nemico da temere. Il compito di genitori e adulti non è far contare calorie ai bambini né dividere i cibi in buoni o cattivi, ma guidarli a costruire una relazione serena e positiva con il cibo. Significa proporre una varietà di alimenti, favorire frutta, verdura, cereali, legumi e pesce, senza demonizzare nessun cibo e senza creare divieti assoluti. È l’esempio quotidiano che fa la differenza: mangiare insieme, cucinare piatti semplici e colorati, vivere i pasti come un momento di condivisione e non di controllo. È importante restituire ai bambini la gioia del movimento, lasciarli giocare all’aria aperta, favorire lo sport come momento di socialità e benessere. Alla fine, il messaggio che dovremmo trasmettere è semplice e profondo: il valore dei nostri figli non si misura con un numero sulla bilancia, ma nella loro capacità di crescere sani, attivi, curiosi e fiduciosi in sé stessi.

Cibo per il cervello: la dieta che accende la mente
Ci sono giornate in cui ci sentiamo carichi, lucidi e veloci a pensare, e altre in cui la concentrazione sembra non voler arrivare. La differenza, spesso, non dipende solo dal sonno o dallo stress, ma anche da ciò che mangiamo. Il cervello, infatti, è un organo affamato: rappresenta appena il due per cento del nostro peso corporeo, ma consuma quasi un quinto dell’energia che assumiamo. E questa energia arriva soprattutto dal piatto. Il carburante principale per i nostri neuroni è il glucosio, cioè lo zucchero che ricaviamo dai carboidrati. Pane, pasta, riso, patate e frutta sono quindi alleati naturali della mente, a patto di sceglierli nelle giuste quantità e nelle versioni integrali, che rilasciano energia lentamente e senza bruschi cali. Più che eliminarli, occorre imparare a usarli con consapevolezza, così da garantire al cervello un flusso continuo di “benzina buona”. Ma non si tratta solo di energia: servono anche i mattoni giusti. Le ricerche mostrano che i modelli alimentari ispirati alla dieta mediterranea, ricchi di verdure, frutta fresca e secca, legumi, cereali integrali e pesce azzurro, aiutano a mantenere viva la memoria e a rallentare l’invecchiamento cerebrale. L’olio extravergine d’oliva e i semi oleosi offrono grassi benefici e sostanze protettive, mentre alimenti come il cacao amaro e il tè verde, ricchi di composti naturali chiamati flavanoli, sembrano potenziare alcune aree della memoria, soprattutto negli anziani. All’opposto, cresce l’attenzione sugli alimenti ultraprocessati: snack confezionati, dolci industriali, piatti pronti. Chi ne consuma molti, dicono diversi studi, va incontro più facilmente a un calo delle funzioni cognitive e a un maggior rischio di malattie neurologiche. Non serve privarsene del tutto, ma imparare a ridurli sostituendoli con cibi freschi e semplici. Il cervello però non vive di sola alimentazione: ciò che mettiamo nel piatto funziona ancora meglio se abbinato a movimento regolare, sonno di qualità, stimoli mentali e una vita sociale ricca. È l’insieme dello stile di vita che rende la mente più resiliente. In definitiva, non servono formule magiche o pillole miracolose. Bastano piccoli gesti quotidiani: un piatto colorato di frutta e verdura, una porzione di pesce azzurro, una manciata di frutta secca, carboidrati scelti con criterio e meno confezioni industriali nella dispensa. È così che si costruisce, giorno dopo giorno, una mente più lucida ed energica. Perché il cervello, come un motore prezioso, non chiede di essere sostituito: chiede semplicemente il carburante giusto.

Cibi ultra processati e obesità: una relazione da conoscere per proteggere la salute
Negli anni, il cibo è diventato molto più di un semplice mezzo per nutrirci: è cultura, identità, piacere. Ma è anche, inevitabilmente, un attore protagonista nella nostra salute. Parlare di obesità oggi significa affrontare una condizione complessa, che coinvolge moltissimi fattori: genetici, ambientali, psicologici, sociali. In questo contesto, i cibi ultra processati sono emersi come uno degli elementi che possono contribuire allo sviluppo e al mantenimento dell’obesità, non tanto per un effetto diretto o automatico, quanto per l’interazione sottile e persistente che hanno con i nostri comportamenti alimentari, il metabolismo e l'equilibrio del nostro organismo. I cibi ultra processati non sono semplicemente "piatti pronti" o "snack confezionati": si tratta di prodotti industriali che spesso contengono ingredienti che difficilmente useremmo nella nostra cucina, come additivi, emulsionanti, aromi artificiali o dolcificanti intensi, e che vengono sottoposti a processi tecnologici che alterano profondamente la matrice originale degli alimenti. Questi alimenti sono pensati per essere iperappetibili, facili da consumare, spesso economici e pronti all’uso. Ed è proprio questa combinazione che, in modo silenzioso ma efficace, tende a modificarne il consumo, favorendo una maggiore densità calorica e una minore qualità nutrizionale della dieta complessiva. Chi vive con l’obesità sa quanto possa essere difficile, a volte, distinguere ciò che è utile da ciò che è colpevolizzante. È importante quindi sottolineare che non esistono cibi 'buoni' o 'cattivi' in senso assoluto. Ma alcune scelte alimentari possono proteggerci, aiutarci a sentire meglio il senso di fame e sazietà, sostenere il benessere intestinale, limitare l’infiammazione e favorire un rapporto più equilibrato con il cibo. I cibi ultra processati, se presenti in maniera regolare e abbondante nella dieta, sembrano invece contribuire ad alterare questi meccanismi di autoregolazione. Studi recenti suggeriscono che, anche a parità di calorie, una dieta ricca di questi prodotti può portare a un maggiore aumento di peso, probabilmente perché interferisce con i segnali cerebrali di sazietà, spingendo a mangiare di più e più velocemente. Queste dinamiche sono particolarmente delicate quando si parla di bambini. Durante l’infanzia, infatti, si formano abitudini alimentari che tendono a consolidarsi nel tempo, e il palato si abitua precocemente a gusti intensi, dolci o salati, tipici degli alimenti ultra processati. Un’esposizione precoce e frequente a questi prodotti è associata a un rischio aumentato di obesità infantile, oltre che a carenze nutrizionali. Più che demonizzare un biscotto o una merendina, il punto è riflettere su quanto spazio occupino questi alimenti nella dieta quotidiana dei più piccoli, e quanto invece sia importante garantire una base di alimenti freschi e poco trasformati, capaci di educare il gusto e fornire nutrienti essenziali per la crescita. Un altro aspetto cruciale riguarda il microbioma intestinale, cioè l’insieme di microrganismi che vivono nel nostro intestino e che svolgono funzioni fondamentali per la salute metabolica, immunitaria e persino mentale. I cibi ultra processati, soprattutto quelli ricchi di emulsionanti, dolcificanti artificiali e additivi, sembrano alterare in modo significativo la composizione e la diversità del microbioma. Questo squilibrio, chiamato disbiosi, può contribuire allo sviluppo di uno stato infiammatorio cronico di basso grado e a una maggiore predisposizione all’aumento di peso, oltre che ad alterazioni del metabolismo degli zuccheri e dei grassi. Tutto questo non significa che nella nostra alimentazione non ci sia spazio per la flessibilità o per il piacere. Il cibo ha anche una dimensione sociale ed emotiva che va rispettata. Ma prendere consapevolezza del ruolo degli alimenti ultra processati nella nostra dieta, senza colpevolizzazioni, può rappresentare un passo importante verso scelte più equilibrate. Ridurre il consumo di alimenti ultra processati non vuol dire seguire una dieta perfetta, ma costruire uno stile di vita più attento, più presente, più sano. Il cambiamento parte da lì.

Farmaci anti-obesità: come agiscono e in che modo assumerli
Negli ultimi anni, i “farmaci anti-obesità” – in particolare gli analoghi del GLP-1 – sono diventati protagonisti di una nuova fase nella gestione del peso e nella riduzione del rischio di malattie associate all’obesità. Nati inizialmente come terapie per il diabete di tipo 2, questi farmaci agiscono mimando l’azione di un ormone intestinale, il GLP-1, che regola l’appetito, il senso di sazietà e i livelli di zucchero nel sangue. Il risultato? Una riduzione significativa dell’introito calorico, senza dover contare solo sulla forza di volontà. Molte persone che vivono con l’obesità sanno quanto sia complesso perdere peso e, soprattutto, mantenerlo nel tempo. Per questo l’arrivo di molecole come semaglutide e tirzepatide ha aperto nuove e promettenti prospettive terapeutiche. Gli studi clinici parlano chiaro: l’uso di questi farmaci può portare a una perdita di peso superiore al 10-15% del peso corporeo iniziale, un risultato che fino a pochi anni fa si osservava quasi esclusivamente con la chirurgia bariatrica. Tuttavia, è fondamentale chiarire un punto: non si tratta di soluzioni miracolose. L’effetto di questi farmaci è massimo quando vengono inseriti in un percorso che comprende un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e, quando necessario, supporto psicologico o comportamentale. Un importante studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha confrontato l’uso della semaglutide rispetto al placebo in adulti con obesità. Chi assumeva il farmaco ha perso in media il 15% del proprio peso corporeo. Ma è importante sottolineare che tutti i partecipanti seguivano anche un programma strutturato, con una dieta controllata e attività fisica. Risultati ancora più significativi sono emersi in altri studi, in cui il trattamento farmacologico è stato affiancato da un percorso intensivo e personalizzato: dieta ipocalorica, movimento programmato, consulenza comportamentale. In questi casi, il dimagrimento medio ha superato il 16-20%, dimostrando quanto lo stile di vita sia fondamentale per potenziare l’efficacia della terapia. È quindi importante non considerare questi farmaci come una scorciatoia o una soluzione rapida al problema del peso. Oltre a richiedere un’assunzione continuativa nel tempo per mantenere i risultati, la loro efficacia può variare molto da persona a persona. Alcuni ottengono grandi benefici, altri solo una riduzione modesta. Inoltre, è stato osservato che, dopo l’interruzione del trattamento, è possibile andare incontro a un recupero del peso perso. In altre parole, questi farmaci non sostituiscono la dieta, ma possono renderla più efficace, aiutando a controllare l’appetito e a migliorare l’aderenza nel lungo periodo. Sono uno strumento in più, non un’alternativa. Affidarsi solo a un’iniezione settimanale senza modificare le proprie abitudini alimentari e lo stile di vita è un po’ come voler curare l’ipertensione con una pillola, continuando però a consumare troppo sale e a non muoversi mai. È fondamentale ricordare che l’obesità è una malattia cronica e multifattoriale, non una questione di mancanza di volontà. I nuovi farmaci rappresentano un passo avanti nella sua gestione, perché ci permettono di trattarla in modo moderno, scientifico e meno stigmatizzante. Ma la chiave resta sempre un approccio integrato, costruito su misura per la persona. Non esiste un percorso identico per tutti: esiste invece una strategia personalizzata, in cui il farmaco può facilitare il cammino — ma non può sostituire il viaggio.

Mangiare sano fuori casa: è davvero impossibile?
Mangiare in modo sano è spesso associato a piatti preparati nella tranquillità di casa, a una spesa ben pianificata e alla cura nella scelta degli ingredienti. Ed è vero: una buona alimentazione comincia proprio da una buona spesa. Tuttavia, per molte persone questa condizione ideale non è sempre possibile. Impegni di lavoro, turni variabili, pranzi al volo tra una riunione e l’altra, viaggi frequenti o semplicemente il desiderio di socializzare intorno a un tavolo fuori casa, rendono i pasti “on the go” una realtà quotidiana. Questo significa dover rinunciare a mangiare bene? Assolutamente no. Seguire un’alimentazione equilibrata anche quando si è lontani dalla cucina di casa è possibile. Non si tratta di rigidità o perfezionismo, ma di consapevolezza e organizzazione. Il primo passo è cambiare prospettiva: non serve controllare tutto, ma scegliere con criterio ciò che è disponibile. Quando si ha il tempo di prepararsi i pasti da portare, anche solo due o tre volte a settimana, è già un buon investimento sulla propria salute. Preparazioni semplici come un’insalata di cereali integrali con verdure e legumi, una frittata con contorno, oppure un panino integrale con hummus e verdure grigliate, possono essere gustose, bilanciate e facili da trasportare. Avere in frigo o in dispensa ingredienti “salva-pasto” come legumi già cotti, uova, frutta fresca, noci, pane integrale o yogurt bianco, aiuta a comporre velocemente pasti sani anche quando il tempo è poco. Ma cosa succede quando non si riesce a preparare nulla e si deve mangiare fuori casa, magari tutti i giorni? Qui entrano in gioco alcune strategie pratiche. Innanzitutto, la scelta del locale. Sempre più ristoranti, tavole calde, bar e mense aziendali stanno ampliando le loro proposte con opzioni più leggere, vegetali e bilanciate. Saper leggere il menù con attenzione è fondamentale: prediligere piatti con verdure, fonti proteiche magre (come pesce, uova, legumi o carni bianche), cotture semplici (griglia, vapore, forno) e condimenti serviti a parte è un ottimo punto di partenza. Anche i piatti unici, se ben bilanciati, sono un alleato prezioso. Un esempio? Un poke con riso integrale, salmone, avocado e verdure; oppure un piatto di pasta integrale con pomodorini, rucola e ceci. Sono scelte pratiche che nutrono con gusto e senza eccessi. Se il menù non offre alternative soddisfacenti, si può combinare un secondo piatto con due contorni, oppure chiedere una porzione ridotta di primo e un’aggiunta di verdure. Un aspetto spesso sottovalutato è l’ascolto del proprio corpo. Quando si mangia fuori casa, si tende a seguire ritmi esterni o abitudini sociali, dimenticando di ascoltare il senso di fame e sazietà. Fermarsi, respirare, gustare lentamente ciò che si mangia e non sentirsi obbligati a finire tutto il piatto sono piccoli gesti di cura che fanno una grande differenza. Anche chiedere un contenitore per portare via ciò che avanza è un’abitudine intelligente e sempre più accettata. Infine, va ricordato che la qualità della dieta si misura sull’arco di giorni, settimane, mesi: non dipende da un singolo pasto. A volte si potrà scegliere il meglio possibile, altre volte si opterà per ciò che è disponibile. E va bene così. L’alimentazione non è una prova da superare, ma una relazione da coltivare nel tempo, con flessibilità e rispetto verso sé stessi. Mangiare fuori casa può rimanere un momento conviviale, piacevole, persino rigenerante, se affrontato con un approccio equilibrato. Più che cercare la perfezione, impariamo a cercare la coerenza: piccoli gesti ripetuti nel tempo, anche fuori casa, possono contribuire a un benessere autentico e duraturo.

Un’estate meno salata: consigli per difendersi dal sodio in eccesso
Con l’arrivo dell’estate, le nostre abitudini alimentari cambiano: cerchiamo piatti freschi, veloci e pratici, spesso a base di formaggi, affettati o insalate già pronte. Se da un lato questi alimenti sembrano ideali per affrontare il caldo, dall’altro possono diventare una fonte nascosta – e spesso sottovalutata – di sale. Il sale è uno dei condimenti più conosciuti e utilizzati nelle cucine di tutto il mondo, ed è una sostanza fondamentale per l’organismo umano. È coinvolto nella regolazione dell’equilibrio idrico, nella trasmissione degli impulsi nervosi e nella contrazione muscolare, compresa quella del cuore. Tuttavia, come spesso accade in nutrizione, è la quantità a fare la differenza tra beneficio e rischio. Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, non dovremmo superare i cinque grammi di sale al giorno, una quantità che corrisponde a circa un cucchiaino da tè. Eppure, nella realtà quotidiana, il consumo medio della popolazione italiana si aggira tra i nove e i dodici grammi, più del doppio del limite suggerito. Il paradosso è che solo una piccola parte del sale che assumiamo proviene dalla saliera: la maggioranza è già presente nei cibi industriali e trasformati che consumiamo ogni giorno. Pane, grissini, formaggi stagionati, salumi, snack confezionati (sia dolci che salati), salse pronte, piatti precotti possono contribuire in modo significativo all’introito di sodio, spesso a nostra insaputa. Le conseguenze di un’assunzione eccessiva di sale sono ben documentate dalla letteratura scientifica. Numerosi studi, hanno dimostrato che una riduzione del consumo di sale può portare a una significativa diminuzione della pressione arteriosa, sia in soggetti ipertesi che normotesi. Anche una modesta riduzione, nell’ordine di 4-5 grammi al giorno, può abbassare la pressione sistolica di diversi millimetri di mercurio, con benefici concreti in termini di prevenzione cardiovascolare. In alcuni casi, l’effetto può essere paragonabile a quello di un farmaco antipertensivo, ma senza effetti collaterali. L’eccessivo consumo di sale può favorire, oltre all’aumento della pressione arteriosa, anche fenomeni come la ritenzione idrica, la sensazione di gonfiore. Va poi considerato che, con il caldo, aumenta la sudorazione e con essa la perdita di sali minerali: ciò può indurre alcune persone a ricercare inconsciamente cibi più saporiti, accentuando ulteriormente l’apporto di sodio. Cosa possiamo fare, dunque, per ridurre l’eccesso di sale senza rinunciare al piacere del cibo? Innanzitutto, è utile abituarsi gradualmente a sapori meno salati, perché il palato si adatta facilmente. Chi è abituato a salare tutto rischia di non percepire il gusto naturale degli alimenti. Un primo passo è quello di ridurre il sale aggiunto in cottura o a crudo, utilizzando invece erbe aromatiche, spezie, succo di limone, aceto o scorza di agrumi, che possono esaltare il gusto senza aggiungere sodio. È fondamentale poi leggere attentamente le etichette degli alimenti confezionati, soprattutto per quelli che sembrano insospettabili: pane e i suoi sostituti, cereali da colazione, zuppe pronte, formaggi, salse da condimento e perfino dolci! Molti prodotti riportano il contenuto di sodio invece che di sale, ma il calcolo è semplice: per sapere quanti grammi di sale ci sono, basta moltiplicare i grammi di sodio per 2,5. Un altro accorgimento utile è quello di scegliere pane e prodotti da forno a ridotto contenuto di sale, ormai presenti in molti supermercati e forni artigianali. Anche limitare il consumo di salumi, formaggi stagionati e pesce conservato (come il tonno in lattina) a non più di una o due volte a settimana può fare la differenza. In alternativa, si possono preferire formaggi freschi e naturalmente meno salati, come la ricotta. Inoltre, privilegiare la cucina casalinga rispetto ai piatti pronti consente un maggiore controllo su ciò che si mangia, evitando condimenti eccessivi o nascosti. Infine, ricordiamoci che una dieta ricca di frutta e verdura, cereali integrali e legumi non solo aiuta a ridurre il sodio, ma apporta potassio, un minerale che bilancia gli effetti del sodio sull’organismo e protegge la pressione arteriosa. Anche l’idratazione gioca un ruolo chiave: bere a sufficienza, soprattutto nei mesi caldi, favorisce l’eliminazione del sodio in eccesso attraverso l’urina e aiuta a mantenere l’equilibrio idrosalino. Il messaggio, in conclusione, è semplice ma potente: il sale non va demonizzato, ma va usato con consapevolezza. In una società in cui i gusti forti e decisi sono esaltati dall’industria alimentare, imparare a ridurre il sale diventa un gesto di attenzione verso sé stessi, il proprio cuore e la propria salute. Anche in estate, con pochi accorgimenti e un pizzico di creatività in cucina, è possibile mantenere il piacere della tavola senza eccedere con il sodio. La salute, in fondo, comincia proprio da ciò che mettiamo nel piatto ogni giorno.

Senza glutine, lattosio o lievito? Quando serve davvero e quando è solo moda
Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a eliminare alimenti dalla propria dieta con l’idea di “stare meglio”: niente glutine, niente latticini, niente lievito. Spesso queste scelte nascono da informazioni lette online, consigli di amici o semplicemente perché “ci si sente gonfi dopo aver mangiato”, senza riuscire a capire cosa esattamente causi questo disagio. Il problema è che molte volte queste restrizioni vengono adottate senza una diagnosi medica o il supporto di un professionista, e questo può avere conseguenze tutt’altro che positive per la salute. Prendiamo l’esempio del glutine. Per chi soffre di celiachia, l’eliminazione del glutine è imprescindibile per prevenire danni all’intestino e complicanze sistemiche. Al di fuori di questo contesto, però, molti scelgono autonomamente di seguire una dieta gluten free, convinti che porti benessere, perdita di peso o maggiore energia: stime recenti parlano di circa un terzo della popolazione che riduce o elimina il glutine solo per motivi di salute percepita. Il problema è che chi elimina il glutine senza un motivo valido può andare incontro a effetti negativi: carenze di fibre, vitamine del gruppo B, minerali, e un aumento di alimenti ultra-processati (spesso più costosi e meno nutrienti). In alcuni casi si è osservato anche un incremento di peso e alterazioni del microbiota intestinale. Anche gli alimenti contenenti lattosio vengono spesso allontanati perché creduti “meno leggeri”, e non perché ci sia un’intolleranza accertata. L’intolleranza al lattosio è causata da una ridotta attività dell’enzima lattasi, che serve a digerire questo zucchero presente nel latte. Ma non si tratta di un “tutto o niente”: esistono diversi gradi di tolleranza. Alcune persone riescono a consumare piccole quantità di latticini, soprattutto se inseriti in pasti completi, mentre altre avvertono disturbi anche con minime dosi. In certi casi, la difficoltà nel digerire il lattosio può essere temporanea, ad esempio dopo un’infezione intestinale o un ciclo di antibiotici che ha alterato la flora intestinale. Quando l’equilibrio del microbiota si altera – una condizione chiamata disbiosi – può ridursi non solo la capacità di digerire il lattosio, ma anche quella di tollerare altri zuccheri fermentabili, detti FODMAP. Questi si trovano in molti alimenti comuni, come alcuni cereali, frutta, verdura, legumi e derivati del latte. In queste situazioni, i sintomi (gonfiore, gas, crampi, diarrea) non dipendono da un’allergia o da un’intolleranza “classica”, ma da una sensibilità intestinale più complessa, che richiede una valutazione attenta. Un discorso simile riguarda anche il lievito, spesso accusato di essere responsabile di gonfiore o pesantezza dopo pasti a base di pane o pizza. In realtà, una vera intolleranza al lievito è molto rara. Nella maggior parte dei casi, i disturbi dipendono da impasti poco digeribili, farine raffinate, lievitazioni troppo brevi o condimenti ricchi di grassi e zuccheri. Anche chi soffre di intestino sensibile o disbiosi può avere difficoltà a digerire certi prodotti lievitati, ma questo non significa doverli escludere del tutto. A volte basta scegliere alimenti realizzati con ingredienti semplici e tempi di lievitazione lunghi, oppure consumarli in modo più consapevole, in quantità moderate e all’interno di pasti bilanciati. È per questo che il ruolo del professionista della salute è fondamentale. Intraprendere da soli una dieta restrittiva può portare a squilibri nutrizionali, carenze di vitamine e minerali, perdita di massa muscolare e peggioramento della qualità della vita. Inoltre, eliminare certi alimenti senza un motivo reale può rendere più difficile una successiva diagnosi, se i sintomi dovessero persistere. Anche se molte persone riferiscono di sentirsi meglio dopo aver eliminato determinati alimenti, il miglioramento spesso non è dovuto all’esclusione del glutine o del lattosio in sé, ma piuttosto a un generale cambiamento delle abitudini alimentari: si riducono i cibi ultra-processati, si fa più attenzione alla qualità degli ingredienti e si introducono alimenti freschi e meno zuccheri. Il beneficio, quindi, potrebbe derivare da uno stile alimentare più sano nel complesso, e non da una singola esclusione.

Il gelato può sostituire un pasto? Ecco come inserirlo nella dieta
Con l’arrivo del caldo, è del tutto naturale che il gelato diventi uno dei protagonisti della nostra alimentazione quotidiana. Più che normale, è quasi fisiologico: le alte temperature stimolano il desiderio di alimenti freschi, dolci e appaganti, capaci di offrire un immediato sollievo e una piacevole pausa. Il gelato, in particolare, non appaga solo il gusto: ha anche una forte componente emotiva e relazionale. È spesso associato a ricordi d’infanzia, alle vacanze estive, alle passeggiate serali in compagnia. Non è solo un alimento, ma un piccolo rituale che unisce gusto, memoria e condivisione. Proprio per questo motivo, quando arriva la bella stagione, è naturale chiedersi come includere il gelato nella propria alimentazione in modo equilibrato, senza rinunciare al piacere ma tenendo conto anche del benessere complessivo. Oltre al gusto, c’è un aspetto spesso sottovalutato ma importante: la gratificazione sensoriale. Studi sul comportamento alimentare mostrano che il piacere derivante dal consumo di un alimento aumenta quando vengono coinvolti anche il tatto, la vista e la ritualità del gesto. È il caso del gelato nel cono: la croccantezza, la manualità, la lentezza nel mangiarlo rendono l’esperienza più appagante, contribuendo anche a una maggiore consapevolezza nel consumo e, in alcuni casi, a una minore quantità assunta. Tuttavia, anche se si tratta di un piacere legittimo, è bene non trasformarlo in un’abitudine quotidiana. Il gelato, soprattutto nei gusti più elaborati – come quelli alla crema, con salse, biscotti o granelle – può contenere quantità elevate di zuccheri semplici e grassi saturi. Questo non significa che debba essere evitato, ma consumato con moderazione, scegliendo porzioni contenute, preferendo gusti semplici o alla frutta, e, quando possibile, optando per preparazioni artigianali. Una domanda frequente, specie nei giorni di caldo intenso, è se il gelato possa sostituire un pasto. Sebbene occasionalmente possa rappresentare una soluzione pratica, non è un'alternativa nutrizionalmente completa. Il gelato fornisce energia, ma è povero di fibre, proteine, vitamine e sali minerali. Inoltre, il suo elevato indice glicemico può causare un rapido aumento della glicemia seguito da un altrettanto rapida sensazione di fame. Per questo motivo, se manca l’appetito, è preferibile orientarsi verso pasti leggeri e bilanciati, come un’insalata con una fonte proteica o uno yogurt con frutta fresca e frutta secca. Particolare attenzione va riservata a chi sta seguendo un percorso di dimagrimento o convive con il diabete. In questi casi, il consumo di gelato richiede maggiore consapevolezza: è consigliabile limitare le porzioni, scegliere gelati alla frutta artigianali, e verificare sempre gli ingredienti in caso di gelati “senza zuccheri aggiunti”, per evitare dolcificanti che possano avere effetti indesiderati. Inserirlo nel piano alimentare in modo ragionato, può permettere di gestirne meglio l’impatto glicemico senza rinunce drastiche. In definitiva, il gelato è uno dei piaceri più semplici e caratteristici dell’estate. Con qualche attenzione e una buona dose di consapevolezza, può tranquillamente far parte di un’alimentazione varia, equilibrata e soddisfacente. Proprio come una passeggiata al tramonto o una chiacchierata sotto le stelle, il gelato, se scelto e gustato con criterio, può essere uno dei piccoli piaceri che rendono l’estate più dolce.

Dieta ideale: ridurre i grassi o i carboidrati? Studi, differenze e falsi miti
Quando si decide di intraprendere una dieta per perdere peso, ci si trova spesso di fronte a un dilemma: è meglio ridurre i carboidrati o limitare i grassi? Da un lato c'è chi sostiene con convinzione l’efficacia delle diete low carb, che promettono rapide perdite di peso e un miglior controllo della fame; dall’altro c'è chi difende i benefici di una dieta low fat, più in linea con le raccomandazioni nutrizionali tradizionali. Entrambe le correnti possono vantare studi scientifici, testimonianze di successo e logiche convincenti. Tuttavia, quando si analizzano con attenzione le evidenze scientifiche nel loro complesso, emerge un quadro molto più sfumato: difficilmente esiste un’unica risposta valida per tutti, e la realtà, come spesso accade in campo nutrizionale, è fatta di molte variabili individuali. Le diete low carb, che riducono drasticamente pane, pasta, riso e zuccheri, hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni anche grazie a promesse di risultati rapidi. D’altro canto, le diete low fat, nate negli anni ’80 e focalizzate sulla riduzione dei grassi, restano un pilastro di molte linee guida ufficiali. Negli ultimi anni, diversi studi clinici di grande rilevanza hanno messo a confronto questi due approcci dietetici. Nella fase iniziale, spesso i regimi low carb sembrano portare a una perdita di peso più rapida, probabilmente per l’effetto combinato di una riduzione della ritenzione idrica e di un maggiore senso di sazietà indotto dalle proteine e dai grassi. Tuttavia, quando si osservano i risultati sul lungo periodo, in particolare dopo 12 mesi, le differenze tra i due gruppi tendono progressivamente ad attenuarsi, fino a risultare spesso minime o addirittura sovrapponibili. È il caso, ad esempio, di alcuni studi ampi e ben controllati che mostrano come, indipendentemente dal tipo di macronutriente prevalente, il fattore determinante resti la capacità di mantenere il deficit calorico e di aderire al piano alimentare nel tempo. Proprio questa osservazione introduce un aspetto fondamentale spesso trascurato: la personalizzazione. Ogni persona ha una risposta metabolica diversa agli alimenti, influenzata da fattori genetici, ormonali, psicologici e perfino dal microbiota intestinale. Una dieta low carb può funzionare bene per qualcuno che ha una forte resistenza insulinica o tendenza alla fame nervosa, mentre un approccio low fat potrebbe essere più sostenibile per chi ama frutta, legumi e cereali integrali. In entrambi i casi, è importante evitare scelte estreme: né grassi né carboidrati sono nemici da demonizzare, ma elementi da scegliere con attenzione. Esistono grassi buoni – come quelli dell’olio extravergine, della frutta secca o del pesce azzurro – così come carboidrati complessi e ricchi di fibre, che contribuiscono a una dieta equilibrata. In definitiva, ciò che conta davvero è trovare un approccio alimentare che possa diventare parte della propria quotidianità, che si adatti alle esigenze individuali e che consenta di mantenere il benessere senza sacrificare il piacere di mangiare. Perché il vero successo non è seguire una dieta perfetta, ma costruire abitudini sane che durino nel tempo.

Aumento di peso senza mangiare di più? Il ruolo nascosto dello stress cronico
Può sorprendere, ma è possibile aumentare di peso anche senza mangiare di più, soprattutto durante periodi di forte stress. Questo accade perché lo stress attiva meccanismi fisiologici ben precisi, capaci di alterare il metabolismo, l’appetito e il modo in cui il corpo accumula energia. Quando siamo sotto stress – che sia di tipo emotivo, lavorativo o familiare – il nostro cervello attiva una risposta antica, ereditata dai nostri antenati: la cosiddetta risposta “lotta o fuggi” (fight or flight). In questo stato, le ghiandole surrenali (due piccole ghiandole poste sopra i reni) rilasciano ormoni come cortisolo e adrenalina, che preparano l’organismo ad affrontare un pericolo. Il paradosso è che oggi il pericolo non è più un predatore nella savana, ma il traffico del rientro, il parcheggio introvabile al supermercato alle 18:30 o le venti e-mail a cui rispondere prima di cena. Eppure, per il nostro cervello, è come se fossimo ancora in pericolo di vita. E quando lo stress diventa cronico – cioè si protrae per giorni, settimane o mesi – questo sistema inizia a lavorare contro di noi. Il cortisolo, in particolare, è al centro del legame tra stress e aumento di peso. Livelli elevati e prolungati di questo ormone aumentano l’appetito (soprattutto verso cibi ricchi di zuccheri e grassi, i cosiddetti “comfort food”), favoriscono l’accumulo di grasso viscerale – quello che si deposita attorno agli organi interni, più pericoloso per la salute – e riducono la massa muscolare e il metabolismo basale. In pratica, il corpo si comporta come se fosse in carestia, anche se siamo circondati dal cibo. Ma non è tutto: quando siamo cronicamente stressati, dormiamo peggio, ci muoviamo meno e il metabolismo rallenta. Lo stress continuo manda in tilt il sistema che regola la comunicazione tra cervello e ghiandole endocrine, rendendo l’organismo meno sensibile all’insulina. Questo squilibrio può portare a un aumento della glicemia e, nel tempo, elevare il rischio di diabete e sindrome metabolica. Anche l’intestino risente dello stress. Il cosiddetto “secondo cervello” – cioè il sistema nervoso enterico – comunica costantemente con il cervello centrale. In situazioni di stress prolungato, la flora intestinale (microbiota) si altera, si infiamma e diventa meno efficiente nell’assorbire i nutrienti. Il risultato? Gonfiore, stanchezza cronica e ulteriore aumento di peso. La buona notizia è che il legame tra stress e peso non è una condanna. Ridurre lo stress può migliorare sia il benessere psicologico che quello fisico. Anche una camminata quotidiana di mezz’ora può abbassare i livelli di cortisolo, così come tecniche di rilassamento come la meditazione e la respirazione consapevole aiutano a contenere la produzione degli ormoni dello stress. È importante anche seguire un’alimentazione equilibrata, evitando diete drastiche e preferendo cibi ricchi di fibre, vitamine e grassi “buoni”, come il pesce azzurro, la frutta secca e l’olio extravergine d’oliva. Infine, dormire almeno sette ore per notte è essenziale per regolare gli ormoni che controllano l’appetito, come leptina e grelina. Conoscere il legame tra stress e aumento di peso ci aiuta a guardare al nostro corpo con maggiore comprensione e meno giudizio. Non è solo una questione di forza di volontà: è il modo in cui l’organismo cerca di adattarsi a una vita che spesso corre troppo in fretta. Ma, con piccoli gesti quotidiani e un po’ di consapevolezza in più, possiamo ritrovare equilibrio, salute e benessere.

Quando il cibo parla ai nostri geni: la rivoluzione della nutrigenomica
Cosa succede nel nostro corpo quando mangiamo? La risposta può sembrare semplice: digeriamo il cibo, assorbiamo i nutrienti e li utilizziamo per produrre energia. Ma negli ultimi anni, la scienza ha scoperto che il legame tra alimentazione e salute è molto più profondo. Oggi sappiamo che ciò che mangiamo è in grado di comunicare con il nostro organismo, influenzando direttamente il modo in cui le nostre cellule si comportano. È questa l’idea alla base della nutrigenomica, una disciplina relativamente recente che studia come l’alimentazione possa modulare l’attività del nostro corpo, a partire dalle istruzioni contenute nel DNA. Per comprenderla meglio, possiamo immaginare i geni come una sorta di manuale operativo: sono loro a fornire le indicazioni su come ogni cellula deve funzionare. Il cibo, attraverso le sue componenti, può influenzare quando e quanto queste istruzioni vengono seguite. Non si tratta di cambiare il nostro patrimonio genetico – quello resta lo stesso per tutta la vita – ma di regolare il modo in cui i geni vengono attivati o “letti”, un po’ come si regola l’intensità della luce con un dimmer: la lampadina è sempre la stessa, ma possiamo decidere di aumentare o ridurre la luminosità. Tra i modelli alimentari più studiati al mondo, la dieta mediterranea emerge come una delle strategie più efficaci per trasmettere all’organismo i segnali giusti. Non è un caso che da decenni sia oggetto di attenzione scientifica: si basa su un equilibrio nutrizionale semplice ma ben radicato, che include cereali integrali, verdure fresche, legumi, frutta, olio extravergine di oliva, pesce e un consumo moderato di carne. Questa combinazione di alimenti non solo nutre, ma modula attivamente le funzioni cellulari. Studi condotti anche in Italia hanno dimostrato che chi segue uno stile alimentare ispirato alla dieta mediterranea tende ad avere un organismo più equilibrato, con minori livelli di infiammazione cronica e un metabolismo più efficiente. Si tratta di benefici misurabili anche a livello clinico: riduzione del rischio cardiovascolare, miglior controllo del peso, e una maggiore resistenza allo stress ossidativo. In pratica, alcune sostanze presenti negli alimenti tipici della dieta mediterranea – come i polifenoli dell’olio d’oliva, gli omega-3 del pesce e gli antiossidanti contenuti in frutta e verdura – agiscono come segnali che parlano direttamente alle nostre cellule. Questi segnali aiutano l’organismo a mantenere l’equilibrio, sostenendo le funzioni vitali senza innescare reazioni di stress o meccanismi di difesa non necessari. Questi effetti non si vedono solo a lungo termine, ma si riflettono anche nel benessere quotidiano: chi segue una dieta bilanciata riferisce più energia, sonno di qualità migliore e una maggiore capacità di affrontare lo stress. La nutrigenomica, insomma, non ci parla solo del futuro della medicina, ma soprattutto del presente delle nostre abitudini. Le scelte che facciamo ogni giorno – cosa mettiamo nel carrello della spesa, come cuciniamo, cosa portiamo in tavola – influenzano in modo profondo il nostro organismo, fino al livello cellulare. Una dieta ricca di alimenti ultra-processati, zuccheri aggiunti e grassi di bassa qualità tende ad attivare segnali di emergenza: infiammazione, accumulo di grasso, affaticamento cronico. Al contrario, un’alimentazione varia e ricca di alimenti vegetali e poco trasformati, invia segnali positivi: equilibrio, protezione, energia. In quest’ottica, la nutrigenomica ci invita a considerare il cibo non soltanto come fonte di energia, ma come un mezzo attraverso cui guidare e sostenere il buon funzionamento dell’organismo.

 cielo coperto (MC)
cielo coperto (MC)





