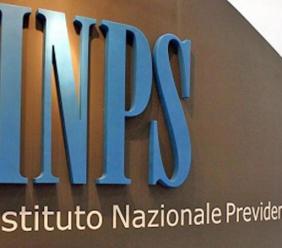di Oberdan Pantana

Dispetti e appostamenti tra vicini di casa: quando scatta il reato di stalking
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le vicende che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Sarnano, che chiede: "A quale responsabilità può andare incontro colui che pone in essere dispetti ed appostamenti nei confronti della propria vicina di casa?". Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini fino ad arrivare a causare quotidiane molestie in danno altrui. A tal proposito, risulta utile riportare una vicenda recentemente affrontata dalla Suprema Corte, nella quale una donna si ritrova a dover fare i conti con un vicino di casa che è un vero e proprio incubo: la pedina, le fa dispetti, la aggredisce verbalmente, la minaccia. A certificare la gravità della situazione è anche il fatto che la donna si sia decisa, alla fine, «ad installare una telecamera di sicurezza ed un piccolo cancello sulla rampa delle scale» così da poter evitare il contatto diretto col fastidioso vicino. A fronte degli elementi probatori raccolti, anche per la Corte di Cassazione la donna è stata vittima del reato di stalking; in particolare, i magistrati sottolineano «la ripetitività e la consistenza dei comportamenti» dell'uomo, comportamenti che «avevano destabilizzato la donna, costretta a ricorrere alle cure di uno specialista per il grave stato di ansia prodottosi» e decisasi, infine, «ad installare una telecamera di sicurezza ed un piccolo cancello sulla rampa delle scale» per provare a ridurre il potenziale pericolo di un contatto con lo sgradevole vicino di casa. Impossibile, quindi, ridimensionare tali episodi nel reato di molestie, poiché le condotte da lui tenute hanno instillato un profondo timore nella vicina di casa, spingendola a «mutare le proprie abitudini di vita» e a «ricorrere a un sistema di videosorveglianza e di difesa della propria casa». Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, "Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di molestie, consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di stalking di cui all'art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato meno grave di molestie di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021 Rv. 281029)". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Quando la rabbia costa cara: condannato per aver staccato luce e gas all'ex moglie
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?" Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13407/2019, secondo il quale: «Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice, a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori». Difatti, proprio in riferimento ad un caso simile a quello prospettato dalla nostra lettrice — nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco — la Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità del reato di cui all’art. 393 c.p. In tal modo, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi, l’ex marito ha agito fuori dai limiti di legge, poiché il diritto poteva essere esercitato solo tramite ricorso al giudice. A tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che «non è consentito legittimare l’autosoddisfazione» per superare gli ostacoli che si frappongono all’esercizio del diritto. Viene, infine, precisato che: «Si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata per difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento del bene, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva e sia impossibile il ricorso immediato al giudice». Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si ritiene corretto affermare che: «Nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria» (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19, depositata il 27 marzo). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Assegno di mantenimento all’ex coniuge: quando spetta e quale funzione ha
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’assegno di mantenimento destinato, in fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al coniuge economicamente più debole. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di San Severino Marche, che chiede: "In quali circostanze viene concesso l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e quale funzione ha?" Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Milano con la sentenza n. 6665/2019 di rigetto dell’istanza proposta da una donna al proprio ex marito, stabilendo espressamente quanto segue: "In considerazione del fatto che la signora possa considerarsi economicamente autosufficiente, anche se con possibilità decisamente inferiori rispetto a quelle del marito, occorre tuttavia sottolineare che alla luce dell'attuale orientamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018) le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscano più il punto di riferimento principale per l'attribuzione del diritto ad un assegno di mantenimento poiché le stesse rilevano solo ove eziologicamente connesse al contributo di ciascuno nel corso della vita matrimoniale, secondo quanto prescritto all’art. 5 comma 6 L. n. 898/1970". (Tribunale di Milano, Sent. n. 6665/2019) Difatti, l’articolo citato nella menzionata sentenza, disciplinando i parametri da valutare al fine del riconoscimento di un assegno di divorzio a beneficio di uno dei due ex coniugi, prevede testualmente che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Per tali ragioni, una volta avanzata la richiesta da una delle parti, il Giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle stesse, e laddove emerga l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, il Giudicante deve accertarne rigorosamente le cause alla stregua dei parametri indicati dal menzionato art. 5. In particolare, deve considerare se quella disuguaglianza economica che emerge sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei due ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età e alla durata del matrimonio. Solo dopo tali valutazioni, il giudice potrà decidere se stabilire un assegno di mantenimento e quantificarlo, senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita coniugale. Pertanto, in risposta al nostro lettore, ed in linea con la più recente e autorevole giurisprudenza, si può affermare che: "All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche funzione perequativo-compensativa, che conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate". (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 18287/2018) Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Matrimonio "in prova": il marito ha diritto al risarcimento?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti interpersonali e nello specifico alle problematiche inerenti le separazioni dei coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Se la moglie contrae comunque matrimonio nonostante l’incertezza dei propri sentimenti verso il futuro marito e poco dopo infatti viene lasciato il marito ha diritto ad un risarcimento danni?” Il caso di specie ci porta ad analizzare una vicenda di recente affrontata dalla Suprema Corte, nella quale, a sei mesi dalle nozze, lei chiede e ottiene in un Tribunale ecclesiastico la nullità del vincolo matrimoniale. A tale scopo sono decisive le parole della donna, la quale riconosce di «avere escluso il bene della indissolubilità del matrimonio e di essersi sposata con l’intenzione di rimanere tale per lo stretto tempo necessario a fare una prova, onde verificare se l’unione potesse reggere», e spiega che «tale intendimento» è stato da lei «totalmente sottaciuto al marito, che ne è venuto a conoscenza soltanto in occasione della causa canonica per la nullità del matrimonio religioso». A fronte di tale quadro, il marito reagisce citando in giudizio la moglie al fine di ottenere un adeguato risarcimento, addebitandole la colpa di «avergli celato la determinazione di sposarsi per prova». Per i giudici di merito però, la pretesa avanzata dall’uomo è priva di fondamento. Così, sia in primo che in secondo grado, si vede respinta la richiesta risarcitoria avanzata. In Tribunale e in Appello, i giudici sottolineano «l’irrilevanza per l’ordinamento italiano dell’esistenza di una causa di invalidità del matrimonio religioso». La vicenda finisce in Cassazione, e gli stessi magistrati pongono in evidenza, come fatto anche dai giudici d’Appello, «l’assenza di un comportamento da parte della donna che possa essere configurato quale produttivo di un danno ingiusto, o altrimenti pregiudizievole sulla base di una sorta di responsabilità prenegoziale». L’assunto di fondo dell’uomo è «la denuncia della portata dannosa della mancata comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione delle nozze, della riserva mentale di contrarre il matrimonio per prova, ossia quale esperimento derivante dalla condizione di incertezza della futura sposa circa la possibilità dell’insorgenza di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza». Per quanto concerne la responsabilità risarcitoria per la mancata comunicazione, da parte della donna, della riserva mentale sulla possibile dissolubilità del matrimonio, i magistrati osservano che «la libertà matrimoniale è un diritto della personalità, sancito anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo» e «benché il matrimonio sia un atto di autonomia privata, non può esservi attribuito l’effetto impegnativo del vincolo», anche perché non si può ignorare l’esistente «diritto di chiedere la separazione giudiziale al cospetto di un fatto tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza». Non a caso, in materia di famiglia è previsto «il diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell’altro coniuge, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile alla Costituzione». Per fare chiarezza poi, sottolineano che «l’atto di impegno matrimoniale è rimesso alla libera e responsabile scelta del soggetto, quale espressione della piena libertà di autodeterminarsi al fine della celebrazione del matrimonio. Tale libertà non può essere limitata da un obbligo giuridico di comunicare al proprio coniuge uno stato soggettivo quale l’incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale, avvertendo il soggetto il rischio concreto della sua dissoluzione ed effettuando la scelta matrimoniale nella consapevolezza di tale rischio, ciò che in altri termini comporta un tentativo o prova di convivenza matrimoniale. Affinché tale libertà non sia compromessa dall’incombenza di una conseguenza quale la responsabilità risarcitoria derivante dall’inottemperanza ad un dovere giuridico, la comunicazione, in quanto relativa alla sfera personale affettiva, può comportare esclusivamente un dovere morale o sociale». Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore e in adesione con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che, «La riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è così improduttiva di effetti per l’ordinamento italiano, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio – in conformità, del resto, alla generale irrilevanza della riserva mentale in materia negoziale –, sia dal lato dell’altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l’ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva» (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 05.11.2024 n. 28390). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. (Foto di Pexels da Pixabay)

Privacy e utenze: è illecito cedere i dati personali senza consenso esplicito
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti il trattamento dei dati personali, anche in relazione all’attivazione dei contratti di fornitura delle utenze. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Civitanova Marche: "È legittimo l’utilizzo dei dati personali dei clienti tra gestori senza l’avvenuto consenso esplicito?". Il caso porta ad esaminare una vicenda molto attuale affrontata dalla CEDU (ric. 23215/21 del 25 giugno), tenuto conto che con la fine del mercato tutelato, se una persona non ha scelto un nuovo gestore, verrà passata automaticamente a quello indicato da Arera. La CEDU «ribadisce che il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dal diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8. L'articolo 8 prevede quindi il diritto a una forma di autodeterminazione informativa, che consente alle persone fisiche di far valere il loro diritto alla vita privata per quanto riguarda i dati che, sebbene neutrali, sono raccolti, trattati e diffusi collettivamente e in una forma o in un modo tale che i loro diritti possano essere esercitati. Nel determinare se le informazioni personali conservate dalle autorità riguardassero aspetti di vita privata, la Corte ha tenuto conto del contesto specifico, della natura delle registrazioni, del modo in cui tali registrazioni sono utilizzate e dei risultati che possono essere ottenuti» (L.B. c. Ungheria [GC] del 9/3/23 per le norme internazionali sul tema). È irrilevante che i dati in questione (metratura, indirizzo, nome del proprietario intestatario dell'utenza “fantasma”, ecc.) fossero contenuti nei pubblici registri del catasto o non ceduti a terzi, se utilizzati per la fatturazione delle utenze senza consenso. Il ricorrente, infatti, non aveva prestato alcun consenso consapevole, libero e informato al loro uso e non è chiaro come entrambi i gestori successivi ne siano entrati in possesso. La prassi recente e costante della CEDU, in linea con quella della CGUE, è chiara: sono da considerarsi illeciti tutti i trattamenti dei dati senza consenso informato dell’interessato. Il consenso deve essere espresso, e non possono costituire autorizzazioni valide le seguenti pratiche: - telefonate o visite a domicilio con la scusa che i dati sono pubblici (es. citofono, elenchi telefonici); - inserire nei siti web diciture come “se consulti il nostro sito automaticamente presti il consenso all’uso dei tuoi dati”; - simili modalità non esplicite o inconsapevoli (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 27/6/23). Pertanto, anche in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare:“Cedere i dati del cliente al nuovo gestore senza il suo espresso e consapevole consenso è una violazione della sua privacy ex art. 8 CEDU, con relativo risarcimento del danno subito” (CEDU, decisione del 25.06.2024). Come sempre, rimango in attesa delle vostre richieste via mail e vi do appuntamento alla prossima settimana.

Bullismo a scuola: quando il MIUR è responsabile del risarcimento danni
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al bullismo tra studenti all’interno del contesto scolastico. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “La scuola può essere condannata al risarcimento danni in caso di bullismo tra studenti all’interno dell’istituto?” Il caso di specie ci rimanda ad una vicenda recentemente definita giudizialmente in ambito civilistico, nella quale un genitore si è rivolto al Tribunale chiedendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio figlio minore, vittima di atti di bullismo consumati durante l’orario scolastico, e più precisamente nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, e che avevano visto come autore un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo della vittima. A tal proposito risulta utile ricordare che, per giurisprudenza unanime e consolidata, nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità che originano da condotte di alunni e insegnanti poste in essere nel corso dell’orario scolastico risulta unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, pur avendo quest’ultimi autonoma personalità giuridica. Per l’effetto tali amministrazioni scolastiche agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato e, nelle liti afferenti agli illeciti di “culpa in vigilando”, pertanto, legittimato passivo risulta unicamente il Ministero e mai l’Istituto (ex multis, Corte di Cassazione n. 6372 del 2011). Inoltre, tenuto conto che i soprusi avvenuti all’interno dell’Istituto e durante l’orario scolastico sono riconducibili all’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente addetto alla struttura scolastica, tanto da aver occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali, tale fattispecie è sussumibile sotto la disciplina dell’art. 2048, comma 2, c.c. Comme che testualmente recita: «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». Incombe quindi all’amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito posto in essere dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità ex art. 2048, comma 3, c.c., si libera soltanto in presenza dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (ex multis, Corte di Cassazione, n. 8811 del 2020). Alla luce di tali considerazioni ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Il MIUR è responsabile e pertanto è condannato a risarcire i danni patiti da uno studente rimasto vittima di atti di bullismo consumati nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, ad opera di un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo del bambino ferito, in quanto i soprusi hanno avuto luogo a causa dell’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e non docente addetto alla struttura scolastica (Trib. Potenza, Sez. Civile, sentenza n. 380/21; dep. il 12.04.21)". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Nuova relazione della ex moglie: cosa succede all’assegno di mantenimento
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento alla debenza o meno dell’assegno di mantenimento o divorzile alla ex in caso di una sua nuova relazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana ad un lettore di Tolentino che chiede: “Se la ex moglie ha una nuova relazione tale circostanza fa venire meno la debenza dell’assegno divorzile?” A tal proposito risulta utile portare il principio giuridico applicato dal Tribunale di Como con l’Ordinanza del 12.04.2018, con la quale è stato stabilito che, “Il marito non deve più corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, anche se non convive con il nuovo partner ed è priva di attività lavorativa”. Così ha deciso il Presidente delegato del Tribunale di Como, in via provvisoria e urgente, a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale – quando generalmente vengono confermate le condizioni della separazione – che ha sin da subito esonerato il marito dal dover corrispondere alla ex moglie, l’assegno stabilito in separazione. La donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Fino a poco tempo fa, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse “realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito”. Il Presidente del Tribunale di Como ha però ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna, nello specifico quella di intraprendere una nuova relazione sentimentale (seppur priva del requisito della convivenza) e quella di avere un figlio (scelta che aveva certamente inciso in termini di difficoltà di reperimento di una occupazione lavorativa), non potessero ricadere sul futuro dell’ex coniuge. Infatti, non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21.05.2018, si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona, il quale – in una causa di modifica delle condizioni di divorzio e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como –, ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie. In questo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito (tratte dai social network), che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme “a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza”, e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza). Dunque, costruire una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise. Ecco quindi che, anche in queste pronunce, i Tribunali – nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi: "La formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio". Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "La nuova relazione affettiva instaurata dall’ex coniuge fa venire meno l’obbligo di versare l’assegno divorzile mensile da parte dell’altro coniuge obbligato, purché la detta relazione sia connotata dai requisiti di stabilità e continuità” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 22604/20; depositata il 16 ottobre 2020)". Ed ancora: "Se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita caratterizzato da assistenza morale e materiale, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno" (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 12.12.2023, n. 34728). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Perdita del bagaglio in viaggio: chi risarcisce e come agire secondo la legge
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato eventi che potrebbero accadere in occasione del ritorno dalle ferie estive e nello specifico la "responsabilità dovuta dalla perdita del bagaglio" in capo agli organizzatori della vacanza o comunque del vettore che ha effettuato il viaggio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “In caso di viaggio con pacchetto turistico “tutto compreso” giunta a destinazione davanti al nastro trasportatore dell’aeroporto si concretizza il fatto della perdita del proprio bagaglio. Chi deve risarcire?” Sapere come comportarsi in questi casi e conoscere la corretta procedura da seguire, aiuta a recuperare la calma dopo l'iniziale momento di sconcerto e rabbia e, magari, anche le valigie o comunque il risarcimento danni. Innanzitutto, giova ricordare che in caso di smarrimento, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, la tutela dei viaggiatori, per le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate nei Paesi che vi aderiscono, è assicurata dalla Convenzione di Montreal del 1999, nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che stabilisce all’art. 22 la responsabilità del vettore, prevedendo un risarcimento danni fino a 1.000 DSP (Diritti speciali di prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.134,71; mentre, per le compagnie aeree che non aderiscono a tale convenzione, è previsto un risarcimento pari ad € 20,00 per Kg sino al raggiungimento del peso massimo ammesso al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi. Sulla base della normativa, pertanto, i passaggi da seguire per ottenere un equo ristoro per il danno subito sono i seguenti: innanzitutto, recarsi all’ufficio oggetti smarriti (Lost and found) dell’aeroporto e compilare l’apposito modulo Pir (Property Irregularity Report), descrivendo la valigia ed il suo contenuto; poi, se trascorse le prime 24 ore, il bagaglio non è stato ancora rintracciato, alcune compagnie provvedono il rimborso di una somma per l’acquisto degli articoli di prima necessità, per le quali è quindi necessario conservare scontrini e ricevute. Qualora il bagaglio non venga restituito, il proprietario è tenuto ad inoltrare reclamo alla compagnia aerea entro 21 giorni dallo smarrimento; in caso, invece, di danneggiamento, la richiesta di rimborso deve essere inviata entro 7 giorni. Per i bagagli contenenti oggetti di valore come gioielli, pc portatili, denaro contante, ecc., è sempre consigliabile dichiararne il contenuto al momento del check-in, chiedendo di poter usufruire della “Dichiarazione di valore”, che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato, oppure optare preventivamente per la stipula di una polizza assicurativa, che consente di avere indennizzi superiori a quelli offerti dalle compagnie in caso di furto o perdita. Ad ogni modo, anche in risposta alla nostra lettrice, nel caso in cui tale vicenda non venga risolta in via stragiudiziale, sarà possibile ottenere giudizialmente il risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, quali anche il danno morale considerato come “danno da vacanza rovinata”. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 17724/18, depositata il 06.07.2018)". Inoltre, sempre nella medesima sentenza, la Suprema Corte individua quali soggetti obbligati a risarcire il proprietario del bagaglio perduto, oltre al vettore, anche il venditore od organizzatore del pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni del viaggiatore, salvo la possibilità, da parte di quest’ultimi, di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, e precisamente: "Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo". Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Facebook: è legale pubblicare foto altrui senza consenso? La guida dell'avvocato Pantana
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo dei social network e nello specifico la pubblicazione di foto nel proprio profilo Facebook. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: "È legittimo pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?". Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica ormai quotidianamente utilizzata dai fruitori del social, le cui modalità non sempre risultano del tutto legittime. A tal proposito deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata al consenso, esplicito o implicito, della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 L. n. 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679), poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale. Difatti, l’art. 96 L. n. 633/1941 esplicitamente vieta l’esposizione di un ritratto senza il consenso della persona ritratta; così come l’art. 6 del Regolamento UE dispone la liceità del trattamento solo se l’interessato ha espresso il proprio consenso; ed infine l’art. 10 c.c. stabilisce che, “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Per tali ragioni, in risposta alla nostra lettrice, è corretto affermare che: "La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata al consenso, esplicito o implicito, della persona ritratta. Questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale. Il trasgressore, pertanto, dovrà immediatamente rimuovere le fotografie illegittime dal proprio profilo Facebook, oltreché risarcire la persona ritratta" (Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

“Suo marito l’ha tradita!”: investigatore privato rischia la condanna per diffamazione?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti tra ex coniugi con esplicito riferimento all’attribuzione per colpa della separazione. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche che chiede: "A quali responsabilità può andare incontro l’investigatore privato assunto dalla moglie per provare il tradimento del proprio marito nel successivo giudizio di separazione con addebito di colpa?". A tal proposito risulta utile riportare il caso giuridico nel quale a finire sotto processo per diffamazione è il titolare dell’agenzia investigativa per aver consegnato alla cliente una nota investigativa redatta su carta intestata con cui veniva attribuita al marito una relazione sentimentale con una collega, relazione risalente a due anni e mezzo prima, quando il matrimonio era ancora solido e i coniugi erano lontanissimi dall’idea della separazione. Quel documento è stato poi utilizzato dalla donna, che ha commissionato l’attività investigativa, nel procedimento di separazione personale con addebito, proprio per tale “presunto” tradimento nel quale però veniva riscontrata l’assenza di effettivi elementi di riscontro in merito all’affermazione di tradimento contenuta nella stessa nota dell’investigatore. La vicenda arrivata in Appello vedeva il Giudicante dichiarare che la mail dell’investigatore privato inviata alla cliente, con cui si comunicava che “da indagini espletate emerge che il proprio marito ha una relazione sentimentale da due anni e mezzo circa con una sua collega”, tanto da attribuire esplicitamente una relazione clandestina, iniziata quando era ancora pienamente operante il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, ha un’oggettiva idoneità lesiva della reputazione del coniuge “traditore”, a fronte della clamorosa assenza di elementi di riscontro. Tirando le somme, “è munita di oggettiva idoneità lesiva della reputazione ed è obiettivamente pregiudizievole della reputazione della persona offesa l’attribuzione non veritiera di una relazione clandestina, in costanza di matrimonio, ad uno dei coniugi”. Ciò perché integra lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio. Di conseguenza, descrivere la persona come capace di tradire la fiducia del coniuge, allacciando una relazione sentimentale con un’altra donna, costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione – chiosa il Giudicante. Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "È diffamazione l’attribuzione non confermata da dati certi di una relazione clandestina in costanza di matrimonio da parte dell’investigatore privato, il quale non poteva ignorare che la cliente avrebbe fatto di quella notizia uso a proprio vantaggio, mettendone a parte terze persone, in quanto consapevole dello stato di coniuge separando della stessa e che quindi le avesse fornito la notizia della relazione extraconiugale del marito, con l’intento di farle conseguire un vantaggio nel giudizio di separazione” (Tribunale di Roma, 31 ottobre 2018). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Violenza privata: quando costringere il partner a non lasciare la relazione è reato
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema dei rapporti di coppia e le loro evoluzioni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Costringere la propria compagna a non interrompere la relazione può comportare delle responsabilità penali?". A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda risolta poi in Cassazione dopo che i giudici di merito hanno ritenuto palese l'inaccettabile condotta aggressiva tenuta da un uomo nei confronti della compagna, condotta mirata a «non farsi lasciare dalla donna». Per i giudici di primo e di secondo grado infatti è logico catalogare i comportamenti dell'uomo come vera e propria violenza privata nei confronti della donna. Dalla Cassazione ribadiscono richiamando il principio secondo cui «l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa». Ciò significa anche che «la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore», ossia, come detto, «la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa». Per quanto concerne la vicenda, i Giudici della Cassazione condividono in pieno le valutazioni compiute in appello: in sostanza, è evidente «il comportamento intimidatorio» dell'uomo che ha tenuto una condotta concretizzatasi nella «minaccia, anche di morte, rivolta alla compagna se quest'ultima avesse interrotto la loro relazione». Per l’appunto, è logico catalogare come «violenza privata» il modus agendi dell'uomo, diretto «ad imporre un comportamento determinato alla compagna», ossia la prosecuzione della relazione e della convivenza. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “È violenza privata non accettare la decisione della compagna di interrompere il loro legame e pretendere attraverso una condotta aggressiva che il partner porti avanti per forza la relazione e non vada via di casa” (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 20346/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Reato di identità digitale: cosa rischia chi crea un account falso
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo per la generalità degli utenti in connessione, nel porre in essere le più disparate attività. Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: "a quali responsabilità si va incontro qualora venga creato un account con le generalità di una persona terza, per il compimento di acquisti online?" Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42572/2018, affermando la responsabilità penale del soggetto ai sensi dell’art. 494 c.p., la cui norma sancisce espressamente: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno". Difatti, la Suprema Corte adita ha statuito quanto segue: "Integra il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p. , la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica nonché proceda all’iscrizione su un sito e-commerce, servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso ed inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguente all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o ad altri strumenti contrattuali. Tanto in quanto porre in essere una condotta con siffatta modalità è prova che l’agente abbia volontariamente sostituito, per la generalità degli utenti in connessione, alla propria identità quella di altri, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate" (Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018, dep. il 27/09/2018). Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche che tali condotte possono avere, è necessario considerare che in una realtà come quella contemporanea, nella quale si fa un uso sempre maggiore dei sistemi telematici per il compimento di una varietà in crescendo di attività, le credenziali adoperate per l’utilizzo delle varie piattaforme, rappresentano il soggetto agente tanto da costituire un vero e proprio surrogato della persona fisica; dunque, la tutela offerta dal legislatore, è intesa a garantire la pubblica fede ed evitare che l’utilizzo di raggiri e artifizi, nel contesto di una società in continua evoluzione, possano trarre in inganno quanti operano in tali settori. Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: "Chiunque in modo volontario e al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, utilizzi l’identità digitale di un soggetto terzo ignaro e inconsapevole, è punito ai sensi dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno" (Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Femminicidio: via libera del Senato al nuovo reato
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violenza di genere e specificatamente ai casi di femminicidio. Ecco l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana, all’approvazione del disegno di legge che introduce il "reato di femminicidio". Il disegno di legge, approvato all'unanimità dal Senato con 161 voti favorevoli, introduce nel codice penale l'art.577-bis, tipizzando con precisione il nuovo reato di femminicidio per evitare incertezze applicative. La norma sancisce che commette femminicidio «chiunque cagiona la morte di una donna, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna, è punito con l'ergastolo». Il testo, frutto di una mediazione tra i gruppi parlamentari, si distingue per la chiarezza definitoria della fattispecie e si accompagna a una serie di misure collaterali di rilievo: l'estensione del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi anche alle persone non più conviventi ma legate all'autore del delitto da vincoli di filiazione, e l'introduzione di una specifica aggravante che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà se il reato viene commesso con le modalità proprie del femminicidio. Tale aggravante trova applicazione anche in relazione a delitti come lesioni gravi e gravissime, mutilazioni, deformazioni del viso, stalking e violenza sessuale, per i quali la persona offesa dovrà essere informata dell'eventuale richiesta di patteggiamento e potrà depositare memorie e deduzioni. Sul piano della prevenzione, il provvedimento rafforza l'utilizzo del braccialetto elettronico, incrementando la distanza minima dalla persona offesa da 500 a 1.000 metri, ed elimina ogni limitazione di durata alle intercettazioni nelle indagini relative a reati di femminicidio e violenza di genere. Centrale è anche l'impegno a potenziare la formazione degli operatori del settore e a rafforzare la protezione delle vittime, ponendo particolare attenzione sia al sostegno ai centri antiviolenza sia alla promozione di programmi di riabilitazione rivolti agli uomini maltrattanti. L'approvazione unanime del provvedimento rappresenta, in definitiva, non solo un salto di qualità nell'arsenale normativo contro la violenza di genere, ma anche un segnale culturale e istituzionale rilevante, che impegna il legislatore e la società civile in uno sforzo condiviso di prevenzione e tutela. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Convivenza di fatto: cosa prevede il contratto e quali sono i diritti riconosciuti ai conviventi
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla convivenza e la sua regolamentazione giuridica. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: "I conviventi di fatto possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune?". Il contratto di convivenza è un accordo grazie al quale una coppia di conviventi, che non sono uniti in matrimonio e che non formano un'unione civile, disciplinano gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I contratti di convivenza, in risposta alla nostra lettrice, sono possibili da quando, il 5 giugno 2016, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, n. 76/2016. Il comma 50 della legge menzionata dispone infatti che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza." Un aspetto importante da segnalare riguarda la legge da applicare ai contratti di convivenza. La legge Cirinnà prevede infatti che agli stessi si applichi la legge nazionale comune dei conviventi, se però i conviventi hanno una diversa nazionalità, allora la legge da applicare è quella del luogo in cui la convivenza è localizzata in via prevalente. I contratti di convivenza consentono alle coppie conviventi di disciplinare, come abbiamo visto, gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I diritti che possono vantare i conviventi però non sono legati solo a quanto stabilito da detti contratti, ma anche dalla disciplina generale prevista per le coppie di fatto. Chi convive gode infatti di alcuni diritti: il diritto reciproco di visita del convivente, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero ospedaliero; i permessi lavorativi retribuiti se si assiste l'altro convivente; la designazione dell'altro convivente come proprio rappresentante per le decisioni sanitarie in caso di incapacità; il diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza intestato al convivente defunto; infine, il diritto agli alimenti nel caso in cui la convivenza venga a cessare. Con i contratti di convivenza le parti disciplinano principalmente il regime patrimoniale della coppia, che può essere di comunione legale, comunione convenzionale o separazione dei beni. I conviventi, come previsto dal comma 4, possono modificare il regime patrimoniale scelto in qualunque momento, purché la modifica rispetti la forma scritta e venga autenticata da avvocato o notaio, che provvederanno anche all’iscrizione all’anagrafe. Ci sono altri dati obbligatori da indicare nell'accordo. Il comma 53 stabilisce che, oltre al regime patrimoniale, il contratto debba contenere l’indicazione della residenza della coppia e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in proporzione alle risorse e capacità lavorative di ciascun convivente. Con i contratti di convivenza inoltre si possono anche disporre trasferimenti immobiliari. Lo prevede il comma 60, secondo cui: "Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza." I contratti, secondo il comma 51, devono essere redatti per iscritto, come atto pubblico o scrittura privata, anche per quanto riguarda modifiche o risoluzioni successive. Avvocati e notai hanno un ruolo molto importante in questi contratti. Sono i garanti della correttezza dell’accordo, in quanto ogni sottoscrizione, modifica o cessazione deve avvenire con la loro autenticazione delle firme. Una volta stipulato il contratto di convivenza, avvocati o notai sono tenuti a trasmetterne copia entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi, per procedere all’iscrizione nell’anagrafe, rendendo così il contratto opponibile ai terzi. Come già ricordato, la forma scritta è essenziale: la mancata osservanza comporta la nullità del contratto. La nullità può verificarsi anche in altri casi: se il contratto è concluso da un minore, un interdetto o da chi è stato condannato per l’omicidio (anche tentato) del coniuge dell’altro convivente. Il contratto è nullo anche se stipulato tra non conviventi, oppure in presenza di un altro contratto di convivenza, un’unione civile o un vincolo matrimoniale. I contratti di convivenza si possono risolvere per accordo tra le parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o con terzi, oppure per morte di uno dei due. Se la coppia ha adottato il regime di comunione legale, la risoluzione del contratto comporta lo scioglimento del regime e, se compatibili, si applicano le stesse regole previste per lo scioglimento della comunione legale nel matrimonio, come da codice civile, sezione III, capo VI, titolo VI del libro primo. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Medico che chiede soldi per il rilascio di un certificato di astensione dal lavoro: quali le responsabilità?
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al Servizio Sanitario Nazionale e nello specifico alla legittimità o meno di richiedere dei soldi da parte del medico ai propri pazienti per il rilascio di un certificato di esenzione dal lavoro. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “E’ legittima la condotta del medico di chiedere dei soldi per il rilascio di un certificato di esenzione dal lavoro?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19409/2025, che si va ad inserire nel solco giurisprudenziale volto a tutelare la legalità e la correttezza dell’azione amministrativa, anche nel settore sanitario, riaffermando il principio secondo cui le prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) devono essere erogate gratuitamente e senza indebite sollecitazioni economiche. Nel caso di specie, un medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, veniva rinviato a giudizio per aver richiesto ai propri assistiti somme di denaro (pari a 30 euro) in cambio del rilascio di certificazioni di astensione dal lavoro. Tali certificazioni, per legge, costituiscono prestazioni dovute nell’ambito del servizio pubblico e, pertanto, devono essere rilasciate gratuitamente. La vicenda arrivata in Cassazione, dove veniva risolta con la conferma della condanna del medico ai sensi dell’art. 322, comma 3, c.p., la cui norma punisce l’istigazione alla corruzione posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, tenendo conto dell’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, del tono della richiesta o la modicità dell’importo richiesto, riguardo invece alla potenzialità dell’offerta a determinare una violazione dell’interesse pubblico tutelato dalla norma. La Corte ha altresì precisato che, per l’integrazione del reato, non è necessario che la condotta sia reiterata nel tempo: è sufficiente un singolo episodio se questo si pone in contrasto con i doveri d’ufficio e con i principi di imparzialità e correttezza che regolano l’azione del medico convenzionato con il SSN. Pertanto, in risposta alla domanda dalla nostra lettrice e in linea con la più autorevole e consolidata giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: “La condotta del medico del SSN che richiede soldi ai propri pazienti in cambio del rilascio del certificato di astensione dal lavoro configura il delitto di istigazione alla corruzione in quanto la sua lesività risiede nella potenzialità dell’offerta indebita indipendentemente dall’effettiva percezione di un’utilità economica o dalla reazione del paziente”(Cassazione Penale, Sez. VI, 28.02.2025, n. 19409). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 poche nuvole (MC)
poche nuvole (MC)