Abilitazioni costosissime e a numero chiuso, corsi informatici e linguistici, master aggiuntivi per perfezionare le proprie conoscenze, un concorso che dovrebbe garantire l’accesso ad un impiego a tempo indeterminato ma che, in realtà, costituisce l’ennesima falla di un sistema alimentato dalla disperazione di persone che farebbero di tutto pur di lavorare. Si tratta del mondo dell’insegnamento, lo stesso cui un tempo si poteva accedere con un diploma e, nella peggiore delle ipotesi, con un concorso. Era semplice: si studiava e poi si entrava a lavorare. Cosa è cambiato da allora?
Innanzitutto, si è acquisita la consapevolezza che, per impartire insegnamenti e per empatizzare con gli studenti, studiare non è sufficiente. Un bravo insegnante deve sì padroneggiare la sua materia, ma anche saper cogliere le diverse sfaccettature all'interno di un’aula: dall’alunno con una situazione familiare difficile, fino a quello con bisogni educativi speciali. Parallelamente a questo, è cambiato il ruolo: un tempo si trattava di un posto "comodo", con il contratto a tempo indeterminato, le tanto invidiate ferie e il prestigio della cattedra, dove c'era la possibilità di usare la bacchetta. Tuttavia, a quel sistema basato sul terrore e sulle ginocchia nude sul grano, è subentrato uno più virtuoso, fondato sull’autorevolezza e sulle note disciplinari.
Fin qui, nulla di sbagliato, se non fosse che ad oggi sono gli stessi insegnanti a dover tornare sui banchi da eterni studenti. I corsi da frequentare e gli esami da sostenere per iniziare ad esercitare la professione sono obbligatori e a pagamento. Il costo dei cosiddetti "percorsi abilitanti", fondamentali per accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), si aggira intorno ai 2.500/3.000 euro: una cifra piuttosto alta, se si pensa al fatto le persone che vi accedono sono costituite principalmente da studenti e neolaureati, categorie prive di una solidità economica per antonomasia. Se una buona parte di essi, però, sa di poter contare sul sostegno finanziario della propria famiglia, alcuni ne restano inevitabilmente esclusi. È una selezione tutt’altro che naturale, piuttosto pecuniaria.
Si tratta di un ingranaggio inceppato già in partenza, a cui si aggiungono tuttavia altri elementi determinanti nel renderlo ancora più discriminatorio e penalizzante nei confronti dei meno abbienti. Dal momento in cui i costosissimi percorsi formativi per l’insegnamento sono praticamente indispensabili per iniziare a lavorare con una certa continuità e che tutti gli aspiranti docenti devono averli frequentati e superati, l’unico modo per salire in graduatoria e avere così maggiore probabilità di essere contattati dalle scuole è raggiungere un punteggio più alto rispetto ai propri colleghi.
E qui subentra l’ennesima strategia di lucro da parte delle università (siano esse pubbliche o private) e dei vari istituti di alta formazione: corsi di perfezionamento da centinaia o addirittura migliaia di euro, certificazioni informatiche e linguistiche, specializzazioni aggiuntive che si rivelano in realtà l’ennesima speculazione su concetti triti e ritriti. Gli stessi esami da superare all’interno di questi “approfondimenti didattici” sono dei veri e propri pro forma - il più delle volte, si tratta di test a risposta multipla ripetibili fino al superamento della prova. Insomma, il meccanismo è chiaro: più si paga, più si ha la possibilità di lavorare. Non è una questione di competenze attinenti alla professione o alle specifiche classi di concorso perché, nell’attuale ordine delle cose, tutto fa brodo: il professore di latino, così come quello di educazione fisica, ottiene ben 6 punti in più con un livello C2 (il più alto che si possa raggiungere) in una lingua straniera, 12 punti con un anno di servizio civile (sta al lettore cercare di immaginare in che modo questa attività possa essere attinente all’ottenimento di una cattedra), 2 punti con strampalate certificazioni informatiche in cui agli “studenti-insegnanti” viene spiegato il funzionamento di un tablet e di una lavagna multimediale - e qui è importante ribadire che i principali destinatari di questo genere di contenuti sono giovani leve perfettamente in grado di utilizzare autonomamente un dispositivo elettronico.
Stando così le cose, non sarebbe certo un’esagerazione parlare di «industria scolastica», un apparente ossimoro che in realtà definisce l'innegabile e fattuale degenerazione del mondo dell’istruzione, in cui alla padronanza della materia si antepone la disponibilità a esborsare cifre discutibili in cambio di punti extra per garantirsi la scalata delle graduatorie. Ancora una volta, però, la colpa non è da ricercare in chi cavalca la crisi del mondo scuola cercando di trarne profitto, né tantomeno in coloro che si adeguano a un sistema che non hanno contribuito a creare: la responsabilità, l’unica, è dello Stato e del Ministero dell’Istruzione, ai quali spetta il compito di risanare i danni provocati negli ultimi anni.
Se davvero si trattasse di competenze necessarie all’esercizio della professione, e non di mere strategie di marketing finalizzate a speculare sulle speranze dei giovani e delle loro famiglie, basterebbe rendere i corsi accessibili a tutti: abbassarne i prezzi e far sì che le istituzioni coprano parte delle spese organizzative, introdurre l’opportunità di frequentare alcuni di questi insegnamenti durante i rispettivi percorsi universitari, includendoli così nella consueta tassazione annuale. Le possibilità, a ben pensare, sarebbero molteplici. Resta da chiedersi, dunque, se le ultime riforme scolastiche siano realmente rivolte al benessere del corpo docente e degli studenti, o non piuttosto al solo interesse delle istituzioni stesse.
Post collegati

San Severino, 40mila euro per la sicurezza: al via il ripristino delle balaustre sui percorsi ciclo-pedonali


 cielo coperto (MC)
cielo coperto (MC)


 Stampa
Stampa
 PDF
PDF




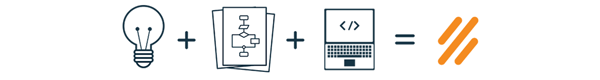





Commenti