Per la prima volta dopo 40 anni Tolentino scende sotto i 18mila abitanti: "Paura che finisca come a L'Aquila"
La crisi demografica che sta investendo tutta l’Italia negli ultimi venti anni ha comportato e sta comportando il graduale invecchiamento della popolazione, il calo vertiginoso delle nascite e il crescente fenomeno emigratorio. In questo quadro già allarmante, le Marche sono fra le regioni che si trovano a dover fronteggiare la ricostruzione post-sisma e il conseguente abbandono delle zone terremotate da parte dei più giovani e di chi può permettersi di acquistare una nuova abitazione.
Il Comune di Tolentino, ad esempio, nel 2022 è sceso sotto il minimo storico dei 18mila abitanti, per la prima volta dopo 40 anni. Stando ai dati demografici rilasciati dall’ISTAT, la città dell’entroterra maceratese al novembre 2022 ospita un totale di 17.944 cittadini, con una predominanza della parte femminile (9260) su quella maschile (8684): un record negativo in linea con le medie nazionali.
Questa contrazione risulta più chiara se si prendono in esame i saldi anagrafici che mensilmente hanno continuato ad assottigliarsi: nel novembre 2022 sono nate 8 persone e 13 sono decedute (-5, saldo naturale anagrafico); 12 si sono trasferite a Tolentino e 27 si sono iscritte in un altro Comune (-15, saldo migratorio anagrafico interno); 5 sono immigrate dall’estero e 6 hanno lasciato l’Italia (-1, saldo migratorio anagrafico estero).
In merito alla situazione specifica di Tolentino, abbiamo raggiunto l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti: “Nel 2016 eravamo in 20mila ad abitare a Tolentino: abbiamo perso quasi 2000 residenti dopo il sisma. In molti, dati tempi lunghissimi della ricostruzione e alcune scelte discutibili dell’amministrazione precedente, hanno deciso di trasferirsi altrove ripartendo da capo”.
“Non ci sono state soluzioni abitative di emergenza assegnate – continua - dobbiamo ancora finire di consegnare gli appartamenti sostitutivi delle Sae e in molti se ne sono già andati. Famiglie con bambini che hanno spostato tutta la loro vita in città più popolose come Macerata o Civitanova, ora non vogliono più tornare a Tolentino. Era nel post emergenza che ci sarebbe dovuta essere un’attenzione particolare verso questo tipo di problematiche e ora ci troviamo a pagarne le conseguenze”.
“La paura, come diceva anche il commissario Castelli, è che succeda come a L’Aquila dove le case vengono ricostruite quando ormai non c’è più nessuno che vuole abitarle – spiega l’assessore - La ricostruzione avrebbe dovuto essere tanto veloce da trattenere gli abitanti che volevano restare e noi ora non possiamo far altro che cercare di mettere una pezza su un buco che si allarga sempre di più, e non è affatto semplice”.
“Da terremotata posso dire che anche io, se avessi ricominciato subito la mia vita fuori Tolentino, non credo sarei mai tornata – conclude Giombetti - se non rimane più alcun legame con la città, che sia la casa, il lavoro o la famiglia, allora non ci sono più motivi di restare. Per chi ha subito una tragedia come quella del terremoto, l’urgenza diventa quella di ritrovare rapidamente un equilibrio. Nel 2016 a Tolentino non si è parlato di SAE quando queste avrebbero permesso di rimanere in loco le famiglie. Non saprei quali soluzioni adottare ora per lo spopolamento, ma se potessi tornare indietro prenderei scelte diverse”.
Per comprendere a pieno la portata di questo fenomeno, basti pensare che l’età media in tutta la provincia di Macerata è passata da 44,2 anni nel 2002 a 47, 3 anni nel 2022 (la media in Italia si attesta a 46 anni), con un calo generale della popolazione totale registrato a partire dal 2011: da 325mila a 304mila abitanti nel 2022.
Questo significa che ci sono sempre meno persone e che quelle che rimangono sono sempre più anziane, proiettando problemi tutt’altro che trascurabili sul lungo termine: l’indice di vecchiaia – il quale determina quanti over 64 ci sono ogni 100 under 15 – è cresciuto costantemente dal 2002, passando da 174,8 a 212,1 (in Italia il valore medio è 183,3) e indicando che per ogni giovanissimo ci sono più di due anziani.
Uno dei primi problemi che ciò comporta emerge dall’indice di dipendenza strutturale, un valore che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione inattiva (under 15 e over 65) su quella lavoratrice (fra i 15 e i 65 anni): in crescita costante da inizio millennio anche questo dato, salito da 55,2 nel 2002 a 62,0 nel 2022 (ogni 100 lavoratori ci sono 62 persone a loro carico).
Nella stessa ottica va letto l’indice di ricambio della popolazione attiva, anch’esso in crescita costante dal 2002, che mette in rapporto quanti sono prossimi alla pensione (60-65) con coloro che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro (15-19): si è passati da un valore di 133,9 a 154,4, in vent’anni. Si consideri che la popolazione attiva è tanto più giovane, quanto il valore è inferiore a 100.
Con un tasso di natalità in calo dal 2009 - passato da 9,3 bambini neonati ogni mille abitanti ai 6,6 del 2021 – e un indice di mortalità oscillante ma generalmente in crescita, sensibilmente aumentato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia – 11,7 morti ogni mille abitanti nel 2019, 13,4 nel 2020, 13,8 nel 2021 - ecco che il preoccupante scenario del Maceratese prende forma.
Tante le motivazioni dietro questa crisi demografica: dalle difficoltà per i giovani nel formare nuovi nuclei familiari, fra il protrarsi dei tempi di formazione e un ingresso instabile e lento nel mondo del lavoro, all’emigrazione consistente che interessa tutte le fasce d’età.
Mentre la popolazione invecchia, i giovani non trovano condizioni adeguate a stabilirsi e fare figli. Ciò comporta un crescente carico sociale sulle spalle della popolazione attiva, con il sistema pensionistico e assistenziale destinato a collassare su stesso. Stando alle stime dell’ISTAT, nel giro di 20 anni la forza lavoro in Italia potrebbe perdere fino a 6,8 milioni di unità, il tutto accompagnato dalla caduta dei tassi di risparmio e dalla sempre maggiore necessità di cure mediche.
Prevenire una catastrofe demografica di tale portata è ancora possibile: da un lato è necessario stabilizzare il mercato del lavoro, incentivando i giovani talenti a rimanere in Italia e a non portare le loro competenze all’estero, garantendo condizioni lavorative ottimali e competitive con il resto d’Europa fra salari, orari di lavoro e precariato (l’Italia è l’unico paese UE dove i salari sono rimasti invariati, se non diminuiti, negli ultimi 30 anni).
Dall’altro bisognerebbe rivedere le politiche migratorie in entrata, cercando quindi di attrarre lavoratori regolari dall’estero in modo da mitigare i cambiamenti strutturali comportati dalla crisi demografica: già nel 2000 i fenomeni migratori da Kosovo e Albania furono decisivi per contrastare il famigerato “Baby bust”, quando i figli per donna erano in media 1,19 (oggi siamo a quota 1,17, con la stabilità della popolazione che sarebbe garantita con una media di 2,2).

 nubi sparse (MC)
nubi sparse (MC)




 Stampa
Stampa
 PDF
PDF






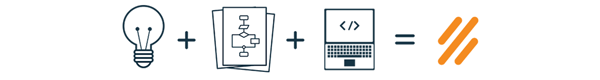





Commenti