San Ginesio, la voce di Pamela Lucciarini porta il '600 italiano all’Auditorium Sant'Agostino
E’ in programma per Domenica 11 ottobre alle ore 18.00 presso l’Auditorium Sant’Agostino di San Ginesio lo spettacolo dell’Associazione Compagnia del Recitar Cantando di Pesaro dal titolo “All’Amore” da” Il Trattato delle Passioni” per la divulgazione del repertorio barocco italiano.
Dopo Ancona, Macerata, Tolentino Macerata, Ferrara a Palazzo dei Diamanti e a Mantova al Festival Trame Sonore, la voce di Pamela Lucciarini e di Guido Barbieri per drammaturgia e narrazione, approderanno a San Ginesio con la poetica degli affetti nella musica italiana del Seicento.
Uno strano, persistente pregiudizio circonda ancora oggi la musica italiana del Seicento. Nella percezione comune è avvertita come “difficile”, complessa, astrusa, lontana dalla sensibilità del tempo presente. Questa diffusa diffidenza ha allontanato e allontana tuttora dai programmi dei teatri e delle sale da concerto musiche di infinita bellezza. Una vera ingiustizia. Il secolo XVII ha creato infatti i tesori forse più preziosi dell’intera storia della musica d’arte italiana. Il repertorio degli oratori, delle opere, dei duetti da camera, delle cantate a voce sola, dei tardi madrigali, dei mottetti, per non parlare delle forme strumentali e della loro stupefacente varietà, contiene pagine che ancora oggi stupiscono, commuovono, fanno spalancare gli occhi. Musiche vocali e strumentali in buona parte ancora da rivelare: almeno al pubblico indifferenziato della musica d’arte.
Una lacuna della quale non si avverte abbastanza la gravità: se le istituzioni culturali italiane dedicassero a questo repertorio un decimo delle risorse che lo Stato francese, ad esempio, ha investito per la riscoperta e la valorizzazione del Seicento parigino potremmo contare oggi su un patrimonio di musiche, di musicisti e di interpreti senza uguali nel mondo. In mancanza di una strategia culturale che parta dal “centro” sono le piccole associazioni musicali “di periferia” a dover svolgere in questo campo una funzione sussidiaria: difficile da praticare, ma indispensabile. Esiste infatti un formidabile anello di congiunzione tra la sensibilità antica e quella contemporanea, un vero e proprio chiasmo comune in grado di avvicinare i lembi di due culture, di due sistemi antropologici apparentemente inconciliabili. E questo ponte così prezioso si chiama “Teoria degli affetti”. Ridotta alla sua essenza è quel complesso, ma trasparente sistema di figure retoriche e poetiche attraverso le quali la musica rappresenta ciò che noi oggi chiamiamo familiarmente “sentimenti”. E che cosa c’è di più immediato, di più facilmente comprensibile del nostro universo emotivo, di quella rete di pulsioni, attrazioni, passioni che costituisce la radice dei nostri comportamenti affettivi? I nomi che noi diamo ai nostri “sentimenti” sono esattamente gli stessi che gli antichi davano agli “affetti”: Ira, Gioia, Tristezza, Furia, Malinconia, Dolore, Nostalgia, Speranza, Odio. Corrispondenze elementari che noi siamo perfettamente in grado di comprendere esercitando con finezza una dote di cui ognuno è in possesso: l’arte di ascoltare. In questo esercizio di conoscenza noi oggi siamo aiutati dalla funzione primaria che la musica degli affetti svolge tra Cinque e Seicento. Non solo rappresentare gli affetti, ma “muoverli”, come si diceva allora: ossia far vivere agli ascoltatori gli stessi medesimi sentimenti che parole e suoni mettono “in scena”. Un nuovo paradigma che insedia, in pieno Umanesimo, una inedita, rivoluzionaria relazione tra il compositore, l’interprete e l’ascoltatore: per la prima vola reso protagonista, quest’ultimo, del viaggio dell’ars musicae. Ognuno di noi, in tutti gli episodi dell’esistenza quotidiana, viene continuamente mosso dagli affetti più contrastanti: per comprendere la musica dei nostri antenati è sufficiente dunque lasciarsi muovere dagli stessi, medesimi affetti che essi stessi vivevano.
Per risvegliare gli affetti nascosti, o sopiti, nella musica vocale e strumentale del Seicento italiano occorre naturalmente adeguare gli strumenti della comunicazione alla sensibilità contemporanea. E guidare l’ascoltatore in una sorta di dizionario moderno degli affetti contenuti nella musica antica. Per questo motivo cercheremo di inserire ogni concerto in una cornice che comprenda innanzitutto – coerentemente con la poetica degli affetti – i sensi percettivi primari: la vista non meno che l’udito. Ogni concerto è immerso, o anche semplicemente accompagnato, da immagini fisse o in movimento che asseconderanno il ritmo e l’ambiente narrativo di ciascun brano o di una sequenza di brani. Ma cerchiamo anche di seguire la naturale, spontanea inclinazione della musica seicentesca alla rappresentazione degli affetti: ossia la sua prorompente, profonda teatralità. La danza e la parola e le altre arti della rappresentazione saranno dunque complementi ideali di ciascun concerto.
Il “trattato delle passioni” che vorremmo scrivere con la complicità degli spettatori è suddiviso in tre capitoli. Per imprimere una forma e una cadenza ai diversi concerti siamo risaliti ad una delle fonti riconosciute della teoria degli affetti, per quanto forse non la più “popolare”: le “Passioni dell’anima” di René Descartes, un piccolo trattato scritto esattamente a metà del secolo, nel 1649. In queste pagine Cartesio offre una classificazione “scientifica” delle passioni umane, suddividendole in primarie e secondarie e sostenendo che ogni azione umana è ispirata da un affetto dominante o dalla combinazione di più affetti. Gli affetti primari sono, per il grande filosofo francese, l’Ira, la Gioia, la Tristezza, l’Amore, la Meraviglia e il Desiderio.

 cielo sereno (MC)
cielo sereno (MC)


 Stampa
Stampa
 PDF
PDF






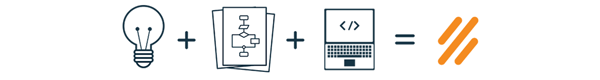





Commenti