Dopo un periodo di interruzione causa sisma ed altre vicissitudini negative, riprendono le attività dell’Erbario dell’Università di Camerino, con nuovo personale entrato in organico a partire dall’inizio di luglio.
L’Erbario UNICAM , struttura della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Ateneo camerte, è ospitato nella storica sede del Palazzo Castelli. Esso è noto a livello internazionale come Herbarium Universitatis Camerinensis ed indicizzato, con la sigla CAME, nell’Index Herbariorum, edito a cura del New York Botanical Garden.
A tutt'oggi l'Erbario UNICAM si compone di circa 250.000 campioni di specie vascolari deposti in oltre 200 armadi metallici e alcune scaffalature, distribuiti in quattro stanze.È organizzato in sezioni distinte per ambiti geografici e comprende in gran parte exsiccata provenienti principalmente dall’Appennino centrale e, in particolare, dal massiccio dei Monti Sibillini, ma anche da territori di altre regioni italiane (Trentino Alto-Adige, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) e in misura minore da altri Paesi europei ed extraeuropei. Una sezione è dedicata alla Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio, da circa 50 anni di proprietà dell’Università di Camerino e gestita dall’Unità Operativa Biodiversità Vegetale e Gestione degli Ecosistemi della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.
L’informatizzazione dei campioni essiccati, finora realizzata nell’ambito del progetto “anArchive”, a cui partecipano 21 enti, tra Università, centri di ricerca ed aree protette, grazie all’assiduo lavoro del Curatore dell’Erbario Domenico Lucarini, recentemente scomparso, consente ad oggi la consultazione online di circa 28.000 reperti di piante vascolari.
Nel 2018 l’Erbario ha inoltre aderito ad un nuovo progetto su scala nazionale proposto dal gruppo “CORIMBO” (Coordinamento della Rete Italiana dei Musei Botanici) della Società Botanica Italiana.Il progetto è in fase di sviluppo, ed è stata avviata la ricerca dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione.
Dal punto di vista storico, l’origine dell’Herbarium Universitatis Camerinensis viene fatta risalire intorno al 1920, ma le prime notizie della presenza di erbari a Camerino risalgono al 1600 circa. I reperti più antichi presenti attualmente si devono ad un raccoglitore anonimo e sono contenuti in un libro-erbario, di 155 piante, attribuibile orientativamente alla seconda metà del Settecento. Alcuni fogli sono corredati da qualche nota autografa attribuita a Vincenzo Ottaviani, professore di botanica e chimica, fondatore dell’Orto Botanico di Camerino e corrispondente di Antonio Bertoloni, autore della Flora Italica (1833-54).
Nell'Erbario esistono anche altri reperti di interesse storico-scientifico raccolti da Pietro Fantozzi (1887), professore di storia naturale nel Liceo di Lucca, Adriano Fiori, Professore al Regio Istituto Forestale di Vallombrosa ed autore della Flora analitica d’Italia (1923-1929) e da altri illustri botanici, quali Anzalone, Brilli-Cattarini, Chiovenda, Lacaita, Marchesetti, Negri, Pampanini, Pichi-Sermolli e Sarfatti.
Fu con l'arrivo di Vittorio Marchesoni a Camerino nel 1951, che si ebbero le prime erborizzazioni di una certa rilevanza, in quanto per un decennio egli si dedicò alla flora dei Monti Sibillini e zone limitrofe, raccogliendo circa 22.300 campioni, metà dei quali è depositata, per volontà dello stesso Marchesoni, presso l’Herbarium Centrale Italicum di Firenze.
La composizione dell'Erbario si arricchì dalla metà degli anni Sessanta, soprattutto per le raccolte di Franco Pedrotti, provenienti principalmente da Italia centrale e Trentino-Alto Adige, e di Sandro Ballelli, le cui esplorazioni botaniche condotte sull’Appennino centrale nell’ultimo quarantennio (in particolare, Monti Sibillini, con circa 50.000 campioni, Monti della Laga, Massicci del Gran Sasso e della Majella), hanno notevolmente incrementato le raccolte e consentito il ritrovamento di specie di notevole interesse fitogeografico, quali la subendemica Campanula alpestris dei Monti Sibillini (che non era stata più ritrovata da circa un secolo), Serratula lycopifolia dell'Altopiano delle Rocche (Abruzzo) e Crepis magellensis della Majella (primo ritrovamento per l'Italia).
Contributi minori si devono anche all'attività di Domenico Lucarini, Ettore Orsomando, Edoardo Biondi, Andrea Catorci, Federico M. Tardella, Carlo Francalancia, Krunica Hruska, Roberto Venanzoni, Roberto Canullo e Riccardo Pennesi.
L’Erbario è a disposizione per la consultazione da parte della comunità scientifica, per lo scambio di campioni con altre sedi universitarie italiane ed estere, ed è aperto agli studenti dei corsi di Biologia, Scienze Geologiche, Naturali e Ambientali e Farmacia. Di rilievo la presenza di erbari didattici che possono essere consultati dagli studenti per imparare le principali caratteristiche sistematiche delle specie e a riconoscere le piante di interesse officinale.
Stretto è anche il rapporto con l’Orto Botanico per quel che riguarda l’identificazione e l’aggiornamento nomenclaturale delle specie botaniche.
A partire dal prossimo autunno, accanto alle finalità scientifiche tradizionalmente riconosciute agli erbari, quali lo studio della sistematica e della biodiversità vegetale, della distribuzione delle specie sulla superficie terrestre e dell’evoluzione storica della flora di un territorio, è prevista l’organizzazione di eventi di carattere scientifico-divulgativo che sono di fondamentale e crescente importanza nell’ambito dell’educazione ambientale e dell’istruzione primaria, secondaria e universitaria.

 poche nuvole (MC)
poche nuvole (MC)



 Stampa
Stampa
 PDF
PDF






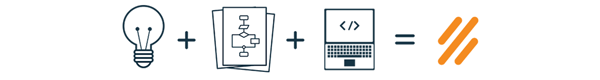





Commenti