Per un Appennino più resiliente: intervento del professor Massimo Sargolini (Unicam)
Dal professor Massimo Sargolini, docente di Urbanistica all'Università di Camerino, riceviamo
In occasione della manifestazione "Tipicità" (organizzata da ISTAO, INU, Ordine degli Architetti di Fermo e dalle università marchigiane), il 6 marzo, si è svolto a Fermo un interessante seminario su "Le Marche dopo il sisma. Ricostruzione, reinsediamento, nuove opportunità, nuovo sviluppo" che ha messo in luce come la cooperazione tra enti di governo, GAL e Università possa fornire nuove opportunità di sviluppo per le aree interne marchigiane.
Il Centro Italia si trova a un bivio molto importante della storia dell'intero Paese. Le scelte di governo che nei prossimi giorni si compiranno, potranno segnare l'avvio di una rinascita o sancire il declino di un territorio di elevato valore culturale e naturale. Peraltro, gli eventi drammatici che hanno interessato l'Appennino marchigiano sono intervenuti in un periodo di profonda crisi economica, in cui ogni decisione di governance sembra in bilico tra desiderio di innovazione, permanenze difficili da gestire e non meglio identificabili "nostalgie del passato", in cui quotidianamente si dibatte sui trend negativi di produzione materiale e le relative convulsioni dei mercati, in cui i casi di povertà reale aumentano ed è a rischio la tenuta sociale. Questa grave incertezza economica s'innesta in uno stato di precarietà degli equilibri ecologici, testimoniato da considerevoli aumenti di inquinamento di alcuni ambienti urbani e periurbani, e da profondi cambiamenti climatici in atto.
Dal processo di ricostruzione delle zone colpite dal sisma si può, tuttavia, ripartire per sviluppare nuove strategie di rigenerazione della città e del territorio.
A partire dalla fine del XX secolo, a livello nazionale ed europeo, incominciano a prodursi le prime importanti riflessioni (all'interno di produzioni legislative, trattati e direttive) che orientano l'uso razionale delle risorse e come queste potrebbero concorrere alla valorizzazione dell'Appennino:
- la Legge Quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 6/12/1991) che connette, attraverso l'uso di appositi strumenti di pianificazione e programmazione, le azioni per la conservazione delle risorse naturali e culturali alle azioni per la loro valorizzazione;
- il Progetto Appennino Parco d'Europa (Legambiente, Ministero dell'Ambiente, 1999), che individua le modalità di reciproca e feconda interazione reticolare tra il cuore naturale della catena montuosa e le aree circostanti, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione. Successivamente, la Carta di Sarnano (Università di Camerino, Alps Convention, UNESCO, 2014), capitalizzando i follow up delle esperienze della Convenzione dei Carpazi e della Convenzione delle Alpi, tenta di creare gli strumenti e gli accordi necessari per la valorizzazione turistica dell'Appennino;
- la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), che mette in gioco una nuova visione di paesaggio, inteso come frutto del rapporto uomo-natura, esteso all'intero territorio (incluse le parti ordinarie e più degradate), da sottoporre alla valutazione da parte di tutta la "popolazione interessata";
- la Strategia Nazionale per le Aree Interne - SNAI (DPS, 2013), che si pone come obiettivo primario lo sviluppo e la ripresa demografica (riduzione dell’emigrazione; attrazione di nuovi residenti; ripresa delle nascite) attraverso l'aumento del benessere della popolazione locale, della domanda di lavoro e di occupazione, del grado di utilizzo del capitale territoriale.
Questi quattro riferimenti per la governance dell'Appennino, nell'affrontare il grande tema della rigenerazione post sisma 2016, non potranno fare a meno di confrontarsi con alcuni obiettivi generali:
1) accrescimento della sicurezza dell'abitare. Diversamente, l'attrattività di questi luoghi si affievolirebbe nel tempo e sarebbe persino difficile riportare a casa quei cittadini che sono stati, temporaneamente, spostati sulla costa;
2) mantenimento sul territorio di un’adeguata offerta di beni/servizi di base, i quali definiscono la “cittadinanza”, che è una condizione fondamentale per garantire il permanere della residenza;
3) miglioramento delle prospettive socio economiche degli abitanti di queste terre, attraverso l'elaborazione di progetti di sviluppo locale in grado di favorire la creatività e l'innovazione e il coinvolgimento delle forze endogene.
Il primo punto dovrà essere soddisfatto preminentemente dallo Stato che è già impegnato nel fornire indicazioni, orientamenti e linee guida riguardo il "come", il "dove" e il "se" ricostruire. Quel che è certo è che il "dov'era e com'era" è ormai solo uno slogan sulla via del tramonto e non potrà applicarsi integralmente, e indistintamente, sull'intero territorio danneggiato.
Riguardo il secondo punto, c'è una compartecipazione tra governo centrale e governi regionali e locali e il primo passo può avvenire da fronti diversi. La stessa Strategia Nazionale per le aree interne si muove in questa direzione e, per formulare alcune prime idee guida, opera in stretto rapporto con le periferie dello Stato.
Riguardo il terzo punto, è proprio il governo locale che deve partire per primo, sapendo che deve uscire dagli angusti e asfittici confini dei campanili e deve saper guardare alle reti globali e quindi all'Europa e al Mondo, passando, se e quando necessario, attraverso il coordinamento della governance regionale e nazionale. Diventa, naturalmente, essenziale il coinvolgimento delle comunità locali e dei soggetti pubblici e privati più idonei alla definizione della proposta strategica.
In questo percorso di rigenerazione, l'Università potrà avere un ruolo speciale. Nel caso studio dell'area del sisma del Centro Italia, l'Ateneo di Camerino ha già svolto un compito straordinario nella fase emergenziale, reagendo, sin dal primo momento, con tempestività e lucidità, mettendo a disposizione le migliori competenze relative all'Architettura, alla Geologia, all'Ingegneria, alla Sociologia e all'Urbanistica, che sono ancora in trincea per valutare danni, mettere in sicurezza, fornire indicazioni per le prime, urgenti, ricostruzioni e la scelta dei siti adeguati all'insediamento temporaneo o permanente. Ora, però, si rende necessario ripensare i territori devastati che presentano inevitabili trasformazioni identitarie, anche interpretando l’immaginario degli abitanti, mobilitando competenze culturali, creative, scientifiche, artistiche e letterarie, favorendo la riflessione su scenari anche diversi, su nuove capacità di immaginare il futuro.
Nel caso più esteso del Centro Italia, all'Università si chiede, dunque, di supportare, dal punto di vista tecnico-scientifico, una nuova visione strategica, nonché la formazione di nuove competenze e nuovi processi organizzativi, che sono sintetizzabili nella cosiddetta "terza missione dell'Università" di cui tante volte, e in diverse sedi, si è parlato, ma la cui applicazione ha presentato, talvolta, ostacoli insormontabili. Mai come in questo momento storico, l'Università è chiamata ad essere imprenditoriale, vale a dire attenta alla promozione della competitività di un territorio, divenendo un hub per l'innovazione in grado di incidere sul benessere sociale ed economico della collettività.
L'Università può offrire dunque un sostegno reale a ritrovare "la coscienza dei luoghi" (Giacomo Becattini) mettendo in luce come una rinnovata interpretazione delle diverse identità territoriali possa favorire una nuova sinergia uomo-natura, strutturale ai fini della cura del territorio, della qualità della vita degli abitanti, della salvaguardia dei caratteri dei luoghi e del patrimonio ambientale e storico-culturale per le generazioni future. Si tratta di interagire, riconoscersi e relazionarsi con le comunità locali, con il loro ambiente di vita e con le dinamiche naturali, per avviare un processo di sviluppo sostenibile costruito sui caratteri, le risorse, le identità e le specifiche dotazioni dei diversi ambienti di vita.
Per avere speranze di successo in questa proiezione è però necessario che l'Università assicuri tre condizioni:
- la formazione, in stretta cooperazione, dei ricercatori che operano nella ricerca per favorire la crescita della conoscenza (ricerca di base) con i ricercatori che operano per favorire il trasferimento e l'applicazione delle conoscenze (ricerca applicata), al fine di incidere sull'innalzamento del benessere sociale ed economico della società;
- il riconoscimento e la valorizzazione del senso e del ruolo della visione interdisciplinare, essenziale per analizzare, interpretare e risolvere i problemi complessi della contemporaneità, che richiedono visioni sistemiche, da ottenere attraverso il contatto ed i mutui scambi tra saperi diversi e complementari;
- la connessione dei percorsi della formazione e della ricerca con i temi della prevenzione e della rigenerazione post catastrofe, anche al fine di attrarre: i) nuovi studenti che troveranno sull'Appennino un grande "centro studi", per approfondire le tematiche della contemporaneità (sisma incluso), con cui dovranno confrontarsi appena proveranno a entrare nel mondo del lavoro; ii) docenti e ricercatori di qualità che desiderano mettersi in gioco e offrire il loro contributo per affrontare le grandi sfide aperte da un Appennino, lacerato, non solo fisicamente, dal sisma e dalla crisi strutturale in corso da tempo.
In conclusione, dalla catastrofe del terremoto si può ripartire per nuovi scenari di rigenerazione e sviluppo solo se coraggiose e visionarie forze di governo, ai diversi livelli, organismi culturali e della ricerca, comunità locali, sapranno cogliere lo stato delle dinamiche in atto, introdurre correttivi e nuovi orientamenti senza aver paura di connettere (anzi con il desiderio di valorizzare) la lentezza e la circoscritta risonanza di alcuni borghi dell'Appennino con la velocità e la vastità delle grandi reti della globalità. Ma soprattutto se si porranno, precocemente, le condizioni per accrescere la resilienza del sistema, cioè la capacità di risposta alle perturbazioni provenienti dall'interno e dall'esterno della nostra area; infatti, "qualora la stessa flessibilità del sistema dovesse ridursi in modo eccessivo potrebbe condurre alla morte dell'organismo" (Ecologia del pensiero, Gregory Bateson).

 nubi sparse (MC)
nubi sparse (MC)



 Stampa
Stampa
 PDF
PDF






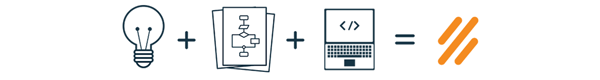





Commenti