Saranno tantissimi i luoghi che si potranno visitare in questa edizione speciale delle Giornate FAI, che assume un’inedita veste “all’aperto”, sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 in oltre 200 luoghi in più di 150 località d’Italia, su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza, grazie all’infaticabile spinta organizzativa dei gruppi di volontari delle delegazioni FAI sparsi in tutto il Paese.
Un’iniziativa per risvegliare la curiosità e l’intelligenza dinnanzi a ciò che ci circonda, per interrogarci – come scrive Goethe – su ciò che abitualmente vediamo ma non conosciamo se non in superficie, e che vedrà protagonisti anche tutti i Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano, per l’occasione anch’essi concentrati su proposte “all’aperto” declinate sul patrimonio verde.
Questa nuova edizione delle Giornate FAI si carica di un significato speciale ed emblematico: il momento storico che stiamo vivendo ha imposto a tutta la collettività di riorganizzarsi e reinventarsi, e il FAI è pronto per tornare a offrire al pubblico una ricca e intensa esperienza di visita, nel rispetto della massima sicurezza per tutti, cogliendo l’occasione per mettere al centro della propria proposta il patrimonio “verde” all’aperto di natura, ambiente e paesaggio del nostro Paese.
Il FAI persegue dalla nascita l’obiettivo di riavvicinare gli italiani alla natura e al paesaggio, per riscoprire e coltivare una "cultura della natura” e per favorire la conoscenza del patrimonio verde dell’Italia, a cominciare dai suoi Beni. Ecco perché dalla crisi generata dalla pandemia ha cercato di cogliere un’opportunità e per la prima volta, dopo 35 edizioni, presenta un programma di aperture interamente dedicato al rapporto tra Cultura e Natura, coinvolgendo i Beni e i territori in cui operano, nell’ambito della missione del FAI, le sue Delegazioni. Sarà sorprendente guardare l’Italia con occhi nuovi, e scoprire tutte le sue molteplici sfumature di “verde”.
Prendere parte alle Giornate FAI è anche un modo per partecipare alla missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione, che negli oltre due mesi e mezzo di chiusura ha interrotto tutte le attività, dalle visite nei Beni ai cantieri di restauro, agli eventi nazionali. Ora il FAI è ripartito, per questo, oltre al contributo minimo – 3 euro per chi è già iscritto al FAI, 5 euro per i non iscritti - richiesto all’atto della prenotazione online, tutti i visitatori potranno iscriversi al FAI con le quote agevolate (riduzione di 10 euro) presso tutti i luoghi aperti e i Beni della Fondazione.
I LUOGHI VISITABILI NELLE MARCHE
Jesi (AN)
Le api raccontano, Oasi WWF di Ripa Bianca. Area, estesa per una superficie di 18 ettari e tutelata dal 1997, è in gestione al WWF Italia. In questo ambiente ricco di biodiversità i visitatori verranno accolti per scoprire il mondo delle api: la loro importanza, la loro vita e il loro ruolo chiave nell'ecosistema.
Corinaldo (AN)
I luoghi dell'immaginazione. La visita condurrà il pubblico alla scoperta della chiesa parrocchiale e della collegiata di San Pietro, di Santa Maria di Piazza, dell’arciconfraternita del Gonfalone e, infine, di Santo Spirito, appartenente all’omonima confraternita. Si tratta di tre delle sette chiese ancora officiate nei primi decenni dell’Ottocento e poi abbandonate per ragioni diverse negli anni successivi all’Unità d’Italia.
Sirolo (AN)
Monte Conero, Abbazia di San Pietro e Incisioni rupestri. Una passeggiata sul Monte Conero tra l'Abbazia di San Pietro, gioiello romanico in vetta al promontorio, e le affascinanti incisioni rupestri risalenti al secondo millennio a. C.
Ascoli Piceno
Giardino vescovile di Palazzo Roverella. Il giardino dei Palazzi vescovili di Ascoli Piceno rappresenta uno dei pochi esempi superstiti di giardino storico di impianto rinascimentale rimasto oggi nel perimetro della città antica. Il Palazzo, che ne costituisce la quinta scenica, fu fatto costruire nel 1532. Il giardino e l’orto erano già esistenti in periodo rinascimentale come testimoniato dalla presenza del pozzo realizzato dal Caffarelli nel 1484.
Fermo
Parco e Oasi della Comunità di Capodarco. Nel Parco della Comunità di Capodarco si estende un bosco di sette ettari di macchia mediterranea e submediterranea con 1300 essenze vegetali tipiche dell’area climato-geografica locale, che oltre a riqualificare l’ambiente costituiscono allo stesso tempo alimento per gli animali presenti sul territorio (uccelli, mammiferi, chirotteri, insetti, anfibi, rettili). L’unicità del posto si riscontra nel fatto che, non essendovi sfruttamento del legname, la riserva si è “rinaturalizzata” in modo spontaneo.
Pesaro
Giardini di Villa Miralfiore. Appartenuta originariamente agli Sforza, la Possessione di Villa Miralfiore fu acquistata nel 1559 dal Duca Guidobaldo II Della Rovere, che ristrutturò completamente l’edificio, alla cui struttura sono addossati i giardini. Nel corso dei secoli il disegno generale d’impianto del giardino è rimasto pressoché inalterato e l’insieme costituisce uno degli esempi più importanti di giardino storico delle Marche.
Fano (PU)
Eremo di Monte Giove. L’architettura riflette il modello dell’Eremo di Camaldoli al quale tutti gli eremi costruiti dai Monaci Coronesi si sono ispirati seguendo le direttive delle Costituzioni di Monte Corona che richiedevano edifici sobri e funzionali. La chiesa, costruita dal 1741, progettata dell’architetto G. F. Buonamici è caratterizzata da uno spazio ottagonale slanciato e luminoso. Le celle dei monaci raccolgono lo spazio per la preghiera, lo studio, il riposo, e un piccolo giardino.
E TRA I BENI DEL FAI
Recanati (MC)
L’Orto sul Colle dell’Infinito racconta il “verde poetico”: la Natura è protagonista nella poesia di Giacomo Leopardi, anche nella celebre lirica L’Infinito, che il poeta ambientò in quest’orto vicino casa e che il FAI oggi racconta in un originale “museo”; l’orto è tornato al suo semplice decoro, con alberi da frutto, ortaggi, viti e rose su pergole, com’era quando a coltivarlo erano le monache del vicino convento; sempre intatto è rimasto l’affaccio sul paesaggio sfumato delle colline marchigiane, che suscitò in Leopardi la ricerca dell’infinito.

 poche nuvole (MC)
poche nuvole (MC)



 Stampa
Stampa
 PDF
PDF






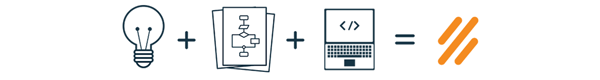




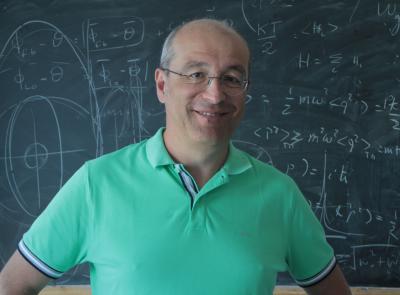
Commenti